Ci sono universi che
prendono forma dal basso, da quello sguardo che si innalza verso il
cielo, ma con i piedi incatenati al suolo. Sono anime che aspirano
in alto, a una felicità promessa, ma mai mantenuta dalla forza di
un destino scomodo, doloroso, umile. Jeong-Sun è
il canto degli ultimi, un poema degli ignorati scritto con
l’inchiostro tinto nel neorealismo, e pennellato di attualità.
E così, nell’opera prima
di Jihye Jeong si ritrovano i fantasmi che hanno
abitato le opere di Rossellini e De
Sica (senza dimenticarci quelle regalateci da un cult come
Parasite); sono esistenze ordinarie, ricche nell’animo
e umili nel contenuto sociale. Ma tra gli inframezzi di
un’esistenza che pare vivere e respirare all’accensione di una
cinepresa, scorre il senso di paura e dolore che colpisce l’animo
femminile, urtandone la sensibilità e deteriorandone la sicurezza.
È il timore di perdere il controllo del proprio corpo, di
tramutarsi in carne da macello per il consumo voyeuristico altrui.
Racconto degli ignorati, e denuncia sociale di un male che
incancrenisce l’essere umano, sviluppandosi in metastasi lungo dita
che scorrono e occhi che scrutano video virali, si muove nell’opera
l’ombra distruttiva del revenge porn e del body
shaming.
Jeong-Sun non si eleva soltanto a prestanome di
una pellicola tanto semplice, quanto umanamente commovente, ma
anche portavoce di tante lacrime nascoste, visi celati sotto
cuscini di vergogna, corpi depredati della propria intimità, ed
esistenze spogliate della propria dignità.
Jeong-Sun, la
trama
Jeong-sun (Kim
Kum-soon) è una donna di mezza età che lavora in una
fabbrica. Attacca quando fuori è ancora buio, accompagnata ogni
giorno dalla figlia (Yun Seon-a), prossima al
matrimonio. Di buon umore e umile estrazione, Jeong-sun finisce per
instaurare una relazione con un nuovo collega, il coetaneo Yeong-su
(Cho Hyeon-woo). Un legame felice e tranquillo,
fino a quando l’uomo non decide di immortalarla in un video che
cambierà l’esistenza di tutti.
Il canto degli
ultimi
È il teatro
dell’esistenza quello allestito da Jihye Jeong nel
suo Jeong-Sun. Una cinepresa fissa, granitica, la
sua, di chi si limita a osservare lasciando che siano i personaggi
a muoversi e infondere linfa vitale alla propria opera. È un cinema
che si nasconde dietro la potenza della quotidianità, che reduplica
lo scorrere della realtà al di là dello schermo, aderendo
perfettamente a quell’ideale di finestra sulla realtà agognata dal
cinema classico. Ma nell’universo filtrato dall’obiettivo di
Jihye Jeong non vi è alcun intento edulcorante
dell’universo colto in essere; ancorandosi a uno sguardo che tutto
coglie e registra dal basso – prendendo cioè corpo da quel
sottosuolo antropologico da cui i suoi stessi protagonisti prendono
vita – la cinepresa di Jihye Jeong si fa
penna adattante un saggio sullo sfruttamento operaio e del corpo
femminile in un paese come quello sud-coreano ancora profondamente
maschilista e dominato da logiche patriarcali.
Duplice colpo al
cuore
Lucido, onesto e
ferocemente sincero, il film è una rappresentazione diretta, ai
margini del documentario, un quadro sociale imbastito con cura
dalla propria autrice. Lontano da ogni manierismo stilistico, e da
virtuosismi registici, la macchina da presa stila un discorso
semplice nel linguaggio, e altrettanto facilmente comprensibile
nella sua lettura. Jeong-Sun scorre sul binario di
un’esistenza ordinaria, ma è proprio grazie a questa esacerbata
normalità, che la sua protagonista si eleva a perfetto testimone, e
massimo rappresentante, di quelle mani che soffocano, e dossi che
rallentano, la serenità delle donne tanto in Sud-Corea, che nel
resto del mondo.
In
Jeung-Sun vivono due anime distinte, e all’interno
di esse scorrono duplici moniti di carattere sociali volti a
schiaffeggiare un sistema ambizioso, che tanto chiede e poco offre.
Ingenua, mite, e perlopiù preoccupata per l’abito da sposa della
figlia, la donna si fa guida dantesca tra le fila di un sistema
aziendale che al merito e alla gratificazione personale, preferisce
un impianto dittatoriale e psicologicamente degradante. Tra notti
spese al lavoro, e minacce da parte di un caporeparto insoddisfatto
della propria esistenza, la Jeong-Sun operaia vive
comunque di un certo ottimismo che la trascina tra i corridoi della
fabbrica a testa alta e il sorriso stampato in faccia. È una donna
che si accontenta delle piccole cose; una calamita umana verso cui
la cinepresa della Jeong non riesce a distaccarsi, inseguendola a
debita distanza e privandosi di movimenti che ne denuncerebbero la
presenza.
Quella che subentra nella
seconda parte dell’opera è invece una donna colpita nell’animo e
depredata della propria intimità. Quella relazione tenuta nascosta,
quasi adolescenziale, con il nuovo collega, si tramuta in culla di
una condivisione social che infanga la reputazione della
protagonista, tra commenti al vetriolo e giudizi taglienti come
lame affilate. Il viso prima sorridente si tramuta in una maschera
del dolore, sfregiato dal tradimento e appesantito da una mole di
sguardi che osservano e sparlano alle spalle. Il corpo di
Jeong-Sun si fa così statua granitica, un automa
che si muove nello spazio d’azione con meccanicità, attivata
soltanto da un’audacia e da una sete di rivendicazione personale
che tutto prende e distrugge con la forza della propria rabbia. Un
cambiamento reso tangibile e tormentato dall’interpretazione
profonda e convincente di una Kim Kum-soon
perfettamente in parte. Non sembrano esistere confini tra l’attrice
e il proprio personaggio: un’unione perfetta che trascina con
naturalezza lo spettatore all’interno della vita della donna,
assimilandone gli attimi di felicità, e interiorizzandone i
fulminei attimi di dolori.
Ambienti che
modellano, sguardi che distruggono
Affidando alla potenza di
campi lunghi, e piani medi, la regista coglie e staglia i propri
personaggi all’interno di un ambiente sociale e lavorativo di cui
essi si elevano a parte integranti e tessere imprescindibili alla
sua perfetta resa visiva. Gli uomini e le donne che scorrono
davanti alla cinepresa vanno oltre la propria natura umana, per
legarsi in maniera armonica al mondo che li circonda; sono universi
che li modellano come cera malleabile, e li influenzano
determinandone scelte e conseguenze di azioni o pensieri. Sono
ambienti illuminati da una luce naturale, sebbene colorata da tinte
fredde, cromatismi gelidi, che tutto rimandano a legami
interpersonali pronti a recidersi e spezzarsi, proprio come iceberg
bruciati dal fuoco della vendetta.
Cristallizzata in una
circolarità eterna, che vive e si sviluppa lungo una reiterazione
di eventi elevati a riti quotidiani, l’esistenza di Jeong-Sun è una
giostra pronta a ripetere ogni giorno, in maniera sempre uguale e
sempre diversa. L’entrata e l’uscita dalla fabbrica, le scatole da
chiudere in catena di montaggio, i rumori del traffico urbano,
l’incontro con l’ubriaca al di fuori del motel, sono punti fermi
nella vita dei personaggi; momenti colmi di sollievo perché carichi
di una quotidianità priva di sorpresa, e per questo di eventuali
minacce.
Inserendosi come un
fulmine a ciel sereno nella tranquillità della propria, ordinaria,
esistenza, la condivisione di un filmato intimo, dove il corpo si
mostra e la bocca canta, è un punto di svolta, un ribaltamento
interiore di una linea che scorre piatta, un extrasistole che
irrompe defibrillando intere esistenze; è l’inedito che distrugge,
per poi ricostruire, un nuovo tempio vitale, nell’attesa di un
ultimo canto liberatorio, in cui la catarsi si sveste di violenza
per esplodere di speranza. Una speranza illusoria, forse, ma
sufficiente per innalzare il punto di ripresa di una cinepresa che
dal basso si alza verso l’alto, verso quel cielo in cui volare
liberi senza pensieri, senza restrizioni, senza mani che scorrono
su cellulari, o labbra che proferiscono ordini con saccente,
tossica, mascolinità.






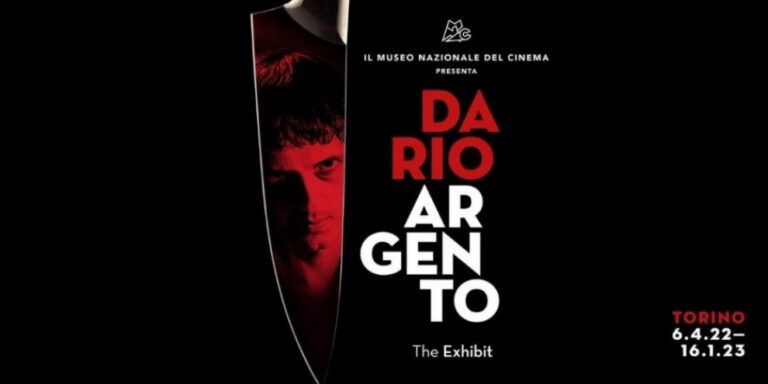

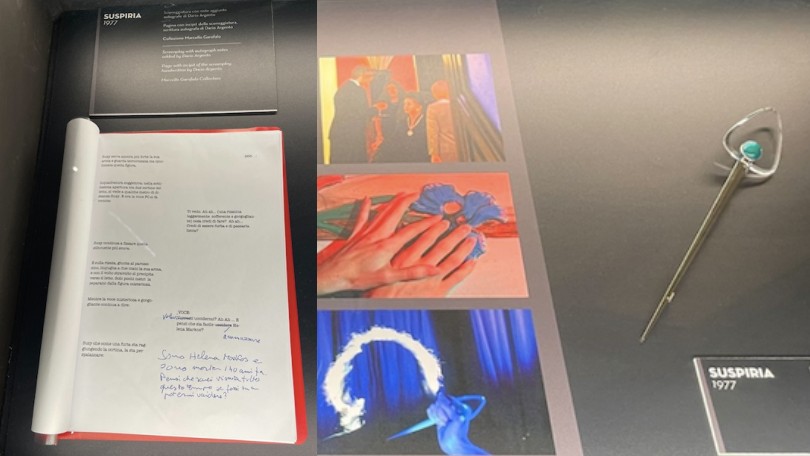







 10. Ha recitato in celebri
serie TV. L’attrice debutta sul piccolo schermo recitando
in alcuni piccoli ruoli in serie come Supernatural (2007),
Aliens in America (2008) e The L World (2009).
Ottiene una prima popolarità grazie a Majority Rules!
(2009). Nel 2012 diventa poi nota per il ruolo di Charlie Matherson
in Revolution, dove recita fino al 2014. Successivamente è
nel cast di MacGyver 2016, dove recita ancora oggi dal
2016. Allo stesso tempo diventa nota per il suo ruolo di Hailey
Upton in
10. Ha recitato in celebri
serie TV. L’attrice debutta sul piccolo schermo recitando
in alcuni piccoli ruoli in serie come Supernatural (2007),
Aliens in America (2008) e The L World (2009).
Ottiene una prima popolarità grazie a Majority Rules!
(2009). Nel 2012 diventa poi nota per il ruolo di Charlie Matherson
in Revolution, dove recita fino al 2014. Successivamente è
nel cast di MacGyver 2016, dove recita ancora oggi dal
2016. Allo stesso tempo diventa nota per il suo ruolo di Hailey
Upton in 

 10. Ha recitato in celebri
prodotti televisivi. L’attrice ottiene una buona
popolarità nel momento in cui recita nella soap opera La valle
dei pini (2008). Con la visibilità raggiunta, entra poi a far
parte di Ugly Betty (2009), con
10. Ha recitato in celebri
prodotti televisivi. L’attrice ottiene una buona
popolarità nel momento in cui recita nella soap opera La valle
dei pini (2008). Con la visibilità raggiunta, entra poi a far
parte di Ugly Betty (2009), con  Yaya DaCosta in Chicago
Med
Yaya DaCosta in Chicago
Med
 10. Ha recitato in celebri
prodotti televisivi. L’attrice inizia a farsi conoscere
sul piccolo schermo grazie al suo ruolo nella serie Squadra
emergenza (1999-2005), dove ricopre il ruolo di Kim Zambrano.
Negli anni recita anche in titoli come 24 (2004-2007),
The Nine (2006-2007), Lipstick Jungle (2008-2009)
e
10. Ha recitato in celebri
prodotti televisivi. L’attrice inizia a farsi conoscere
sul piccolo schermo grazie al suo ruolo nella serie Squadra
emergenza (1999-2005), dove ricopre il ruolo di Kim Zambrano.
Negli anni recita anche in titoli come 24 (2004-2007),
The Nine (2006-2007), Lipstick Jungle (2008-2009)
e  Kim Raver in Una notte al
museo
Kim Raver in Una notte al
museo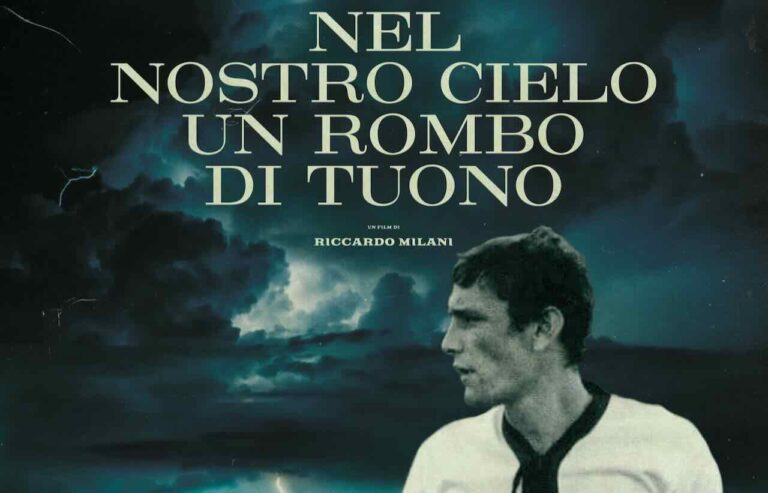


 10. È il protagonista di
una nota serie comedy. Il grande successo
dell’attore è dovuto tutto al ruolo di Sheldon Cooper nella sit-com
10. È il protagonista di
una nota serie comedy. Il grande successo
dell’attore è dovuto tutto al ruolo di Sheldon Cooper nella sit-com
 5. Ha vinto numerosi
premi. Particolarmente apprezzato per il suo ruolo nella
serie, l’attore è stato premiato con ben quattro Emmy Awards come
miglior attore in una serie TV commedia. Sempre per lo stesso ruolo
ha anche vinto un Golden Globe e un Critic’s Choice Television
Awards. È stato poi premiato per due volte come attore preferito in
una serie TV commedia ai People’s Choice Awards. Vanta infine sette
nomination ai SAG Awards e cinque ai Satellite Award.
5. Ha vinto numerosi
premi. Particolarmente apprezzato per il suo ruolo nella
serie, l’attore è stato premiato con ben quattro Emmy Awards come
miglior attore in una serie TV commedia. Sempre per lo stesso ruolo
ha anche vinto un Golden Globe e un Critic’s Choice Television
Awards. È stato poi premiato per due volte come attore preferito in
una serie TV commedia ai People’s Choice Awards. Vanta infine sette
nomination ai SAG Awards e cinque ai Satellite Award.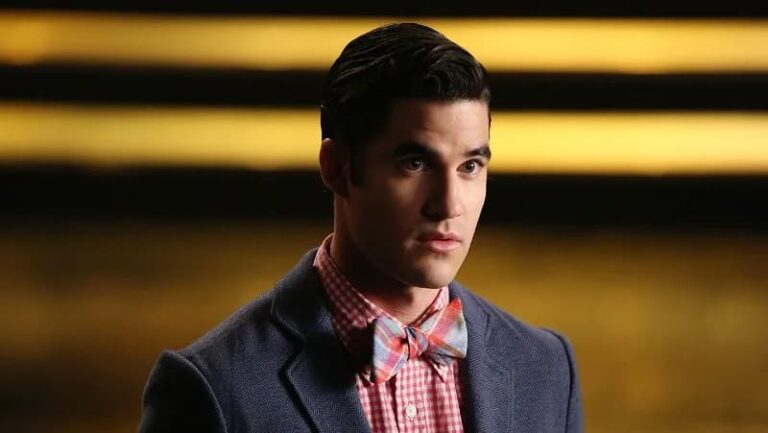



 10. Ha recitato in celebri
prodotti televisivi. Nell’anno del suo debutto l’attrice
ottiene da subito una serie di ruoli che le permettono di diventare
un volto affermato del piccolo schermo. Recita infatti nelle serie
Neighbours (2003-2008), Le isole dei pirati
(2003), e The Sleepover Club (2003-2004), grazie al quale
ottiene maggior popolarità. Successivamente prende parte ad alcuni
episodi di serie come Blue Water High
(2006), Rush (2008), All Saints (2009) e
Nikita (2013), con l’attrice
10. Ha recitato in celebri
prodotti televisivi. Nell’anno del suo debutto l’attrice
ottiene da subito una serie di ruoli che le permettono di diventare
un volto affermato del piccolo schermo. Recita infatti nelle serie
Neighbours (2003-2008), Le isole dei pirati
(2003), e The Sleepover Club (2003-2004), grazie al quale
ottiene maggior popolarità. Successivamente prende parte ad alcuni
episodi di serie come Blue Water High
(2006), Rush (2008), All Saints (2009) e
Nikita (2013), con l’attrice  5. È la protagonista della
serie. Benché sia impostata come un racconto corale, il
cuore delle vicende di The 100 è il personaggio ricoperto
dalla Taylor, Clarke Griffin. Questa assumerà sempre più spazio
all’interno della serie, diventando co-leader del gruppo dei
protagonisti. Proprio per la sua importanza nella serie, l’attrice
è l’unico membro del cast ad essere comparsa in tutti gli episodi
della serie tranne uno.
5. È la protagonista della
serie. Benché sia impostata come un racconto corale, il
cuore delle vicende di The 100 è il personaggio ricoperto
dalla Taylor, Clarke Griffin. Questa assumerà sempre più spazio
all’interno della serie, diventando co-leader del gruppo dei
protagonisti. Proprio per la sua importanza nella serie, l’attrice
è l’unico membro del cast ad essere comparsa in tutti gli episodi
della serie tranne uno.

 10. Ha recitato in celebri
prodotti televisivi. Cumming esordisce sul piccolo
schermo partecipando ad alcuni episodi di serie come Shadow of
the Stone (1987), Take the High Road (1988), The
High Life (1994-1995) e The L World (2006). Diventa
poi celebre grazie al ruolo di Eli Gold nella serie
10. Ha recitato in celebri
prodotti televisivi. Cumming esordisce sul piccolo
schermo partecipando ad alcuni episodi di serie come Shadow of
the Stone (1987), Take the High Road (1988), The
High Life (1994-1995) e The L World (2006). Diventa
poi celebre grazie al ruolo di Eli Gold nella serie 


 Jennifer Morrison in Dr.
House
Jennifer Morrison in Dr.
House 3. Il personaggio
protagonista è stato scritto per lei. Uno dei motivi che
ha portato l’attrice a lasciare la serie
3. Il personaggio
protagonista è stato scritto per lei. Uno dei motivi che
ha portato l’attrice a lasciare la serie 

 10. Ha recitato in celebri
film. L’attore debutta al cinema nel 2008 recitando in
Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, con
10. Ha recitato in celebri
film. L’attore debutta al cinema nel 2008 recitando in
Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, con  Dylan Minnette in Prison
Break
Dylan Minnette in Prison
Break

 Brec Bassinger in
Brec Bassinger in 





 5. Ha diretto un
episodio. Nel 2019, ormai “veterano” della serie, l’attore
decide di esordire alla regia dirigendo l’episodio
5. Ha diretto un
episodio. Nel 2019, ormai “veterano” della serie, l’attore
decide di esordire alla regia dirigendo l’episodio 
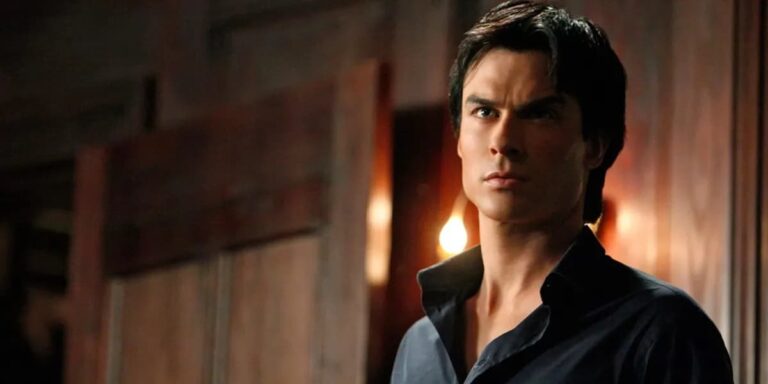

 1. Una vita tra serie
tv. L’attrice ha recitato in moltissime serie tv,
debuttando sul piccolo schermo grazie a Earthsea (2005),
per poi proseguire con Edgemont (2001-2005),
1. Una vita tra serie
tv. L’attrice ha recitato in moltissime serie tv,
debuttando sul piccolo schermo grazie a Earthsea (2005),
per poi proseguire con Edgemont (2001-2005),  8. Ha fondato un sito
web. Insieme alla produttrice della serie, Kendra
Voth, l’attrice ha fondato Girls By Design, un
sito web in cui le ragazze adolescenti possono incontrarsi per
esplorare, esprimere, creare e realizzare insieme le loro
potenzialità. L’attrice partecipa attivamente al sito, presentando
gli scritti di Sima Kumar, Kailin Gow e
Tammy Lelie. Inoltre, hanno collaborato al sito
anche Allison Mack e Caitlin
Crosby.
8. Ha fondato un sito
web. Insieme alla produttrice della serie, Kendra
Voth, l’attrice ha fondato Girls By Design, un
sito web in cui le ragazze adolescenti possono incontrarsi per
esplorare, esprimere, creare e realizzare insieme le loro
potenzialità. L’attrice partecipa attivamente al sito, presentando
gli scritti di Sima Kumar, Kailin Gow e
Tammy Lelie. Inoltre, hanno collaborato al sito
anche Allison Mack e Caitlin
Crosby.