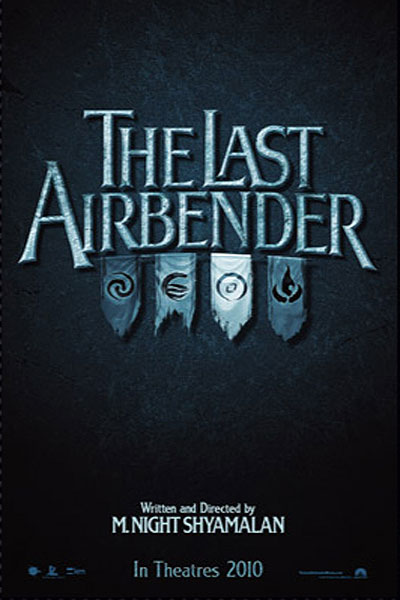Videocracy – Basta apparire (2009), diretto dal regista bergamasco Erik Gandini, è uno dei documentari più discussi e controversi del cinema italiano contemporaneo. Presentato in anteprima al Festival di Venezia, il film affronta senza filtri il rapporto tra televisione, immagine e potere nell’Italia di inizio Duemila, in un’epoca in cui il piccolo schermo non era solo intrattenimento, ma la vera arena politica e culturale del Paese.
Attraverso volti emblematici come Fabrizio Corona, “fotografo-ricattatore” autoproclamatosi Robin Hood, e Lele Mora, talent scout vicino a Silvio Berlusconi, Gandini mostra l’altra faccia dello spettacolo televisivo: un sistema che seduce, manipola e condiziona aspiranti star, vip e spettatori. Il suo titolo – Videocracy – rimanda a un concetto preciso: il governo delle immagini, dove apparire conta più che essere, e la televisione diventa lo strumento privilegiato di un potere che invade ogni aspetto della società.
Videocracy – Basta apparire, la trama: Il film documenta alcuni aspetti della tv italiana, delle reti mediaset, i provini e i tentativi compiuti da un ragazzo per diventare un’icona dello spettacolo televisivo. Vengono raccontate le vicende del fotografo/ricattatore Fabrizio Corona e dello scopritore di talenti Lele Mora.
Videocracy – Basta apparire è un “invisibile”. Presentato al Festival di Venezia nel 2009, ci si sarebbe aspettati di vederlo regolarmente distribuito nelle sale italiane, e invece la sua uscita fu limitata a poche copie e proiezioni sporadiche.
Perché? La risposta è semplice: il film affronta un tema che scotta, il potere delle immagini televisive. La videocrazia. Non a caso sia RAI sia Mediaset si rifiutarono di trasmetterne il trailer, e poche sale accettarono di programmarlo.
Il documentario mostra come il potere delle immagini agisca a diversi livelli:
-
sul giovane di provincia che sogna una carriera in tv,
-
sui VIP resi ricattabili dal gossip,
-
su produttori e spettatori che restano parte di un meccanismo perverso.
Il potere delle immagini
Di questo sistema hanno saputo approfittare alcuni personaggi chiave. Corona, ad esempio, racconta senza remore di essere un “Robin Hood” che ruba ai ricchi per dare a se stesso. Mora, invece, appare come un vero mediatore di potere: mostra con orgoglio il suo cellulare pieno di immagini di simboli fascisti, mentre in sottofondo risuona Faccetta nera.
E ancora: per diventare una “meteorina” di Rete4 bisogna passare per il “Billionaire” di Flavio Briatore, mentre i provini per le veline di Striscia la notizia diventano il rito di passaggio verso una carriera televisiva.
Gandini e la videocrazia
Erik Gandini, regista bergamasco da anni residente in Svezia, mostra come le immagini televisive siano diventate strumento di condizionamento non solo per chi aspira a diventare famoso, ma anche per chi lo è già. Parafrasando Debord, lo spettacolo è un insieme di relazioni sociali mediate dalle immagini, e in Italia questo legame tra immagini e potere è incarnato dall’uomo politico che più di tutti ha fatto della tv il suo strumento: Silvio Berlusconi.
Le reti televisive, specialmente Mediaset, diffondono un modello di edonismo che manipola coscienze e desideri, promettendo all’“everyman” un quarto d’ora di celebrità, warholiano e illusorio.
Estetica e limiti del film
Le immagini del film sono volutamente sgranate, sporche, pastose, come se fossero riprese di uno schermo televisivo. Richiamano i retini pop di Lichtenstein o le immagini usurate di Warhol: fotogrammi già consumati e riutilizzati, digeriti e instillati nello spettatore.
Videocracy – Basta apparire affronta temi scottanti e necessari, e ha il merito di metterli a nudo con chiarezza. Tuttavia, alla sua operazione manca un vero affondo critico sulle dinamiche profonde dello strapotere mediatico: Gandini si limita a mostrare i casi noti (Corona, Mora) senza andare oltre. L’opera resta comunque preziosa come testimonianza di un’epoca in cui lo spettacolo e il potere politico si sono fusi in un unico dominio: quello delle immagini.










 A due anni di distanza dalla Terra dei morti viventi,
Romero, dedito al (sotto)genere degli zombi -da egli stesso
promulgato- torna ad inscenare soggetti che proliferano di morti
viventi. Ma l’ingegnosità del regista sembra inesauribile, e il
quinto capitolo della saga degli zombi, prende una piega del tutto
nuova, inserendosi direttamente nella linea che da Cannibal
Holocaust porta a Cloverfield, passando per The Blair witch
project e REC.
A due anni di distanza dalla Terra dei morti viventi,
Romero, dedito al (sotto)genere degli zombi -da egli stesso
promulgato- torna ad inscenare soggetti che proliferano di morti
viventi. Ma l’ingegnosità del regista sembra inesauribile, e il
quinto capitolo della saga degli zombi, prende una piega del tutto
nuova, inserendosi direttamente nella linea che da Cannibal
Holocaust porta a Cloverfield, passando per The Blair witch
project e REC.