Si svolgerà a Venezia dal 31 agosto al 10 settembre la XIII edizione delle Giornate degli Autori, organizzate dall’Associazione presieduta da Roberto Barzanti, promosse da Anac e 100autori, dirette da Giorgio Gosetti, organizzate con il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiBACT e il contributo di partner pubblici e privati.
 Sezione autonoma e indipendente nel quadro della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, conosciute nel mondo con il brand internazionale di Venice Days, le Giornate sono ormai una realtà strutturale nel più antico festival cinematografico del mondo ma, da sempre, affiancano alla selezione del cinema indipendente di qualità una fitta attività di ricerca, incontri e dibattiti che hanno il loro fulcro nella Villa degli Autori.
Sezione autonoma e indipendente nel quadro della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, conosciute nel mondo con il brand internazionale di Venice Days, le Giornate sono ormai una realtà strutturale nel più antico festival cinematografico del mondo ma, da sempre, affiancano alla selezione del cinema indipendente di qualità una fitta attività di ricerca, incontri e dibattiti che hanno il loro fulcro nella Villa degli Autori.
Prettamente internazionale, con una selezione di prime mondiali e internazionali e con una speciale attenzione all’Europa grazie alla partnership con il Parlamento europeo per il progetto 28 Times Cinema e il Premio LUX, l’immagine delle Giornate degli Autori difende la creatività, l’innovazione e la ricerca dei nuovi linguaggi dell’audiovisivo così come la libera circolazione delle idee.
«Il segno forte di questa selezione – osserva il delegato Giorgio Gosetti – è la creatività femminile che attraversa la gran parte dei film che abbiamo visionato e la maggior parte di quelli selezionati. È la conferma di quell’attenzione all’universo femminile che ormai da anni – anche grazie al creative partner Miu Miu con il progetto “Women’s Tales” – abbiamo posto al centro della nostra ricerca. Ma è anche un segno forte di vitalità e ringiovanimento dell’arte cinematografica che, non a caso, si conferma nell’eccezionale numero e qualità di opere prime e seconde in cui crediamo».
Venti nazionalità rappresentate (comprese quelle degli autori), sette opere prime, sette autrici, tre film italiani realizzati con il contributo del MiBACT, undici titoli in concorso per il Venice Days Award (con una dotazione di 20.000 euro equamente divisi tra il regista e il distributore internazionale) assegnato da una giuria di ventotto giovani europei appassionati di cinema, selezionati in collaborazione con il Parlamento europeo ed Europa Cinemas e coordinati dal direttore artistico del Karlovy Vary Film Festival, Karel Och.
A presiedere la giuria sarà il geniale scrittore, fotografo, regista canadese Bruce La Bruce, già presente alle Giornate nel 2013 con Gerontophilia.
I film europei della selezione concorreranno al Label Europa Cinemas attribuito da una giuria di esercenti, mentre un Premio del Pubblico sarà stabilito dal pubblico della Mostra grazie al contributo di BNL – Gruppo BNP Paribas (main sponsor).
Le opere prime delle Giornate degli Autori concorreranno infine al Premio Luigi De Laurentiis per l’opera prima designato tra gli esordi di tutte le sezioni della Mostra.
Molti dei generi più popolari del racconto per immagini saranno rappresentati in questa selezione, sia pure sotto l’emblema forte dell’originalità espressiva: il documentario (The War Show), il racconto di formazione (Heartstone e Polina), il melodramma (Indivisibili e Pamylia Ordinaryo), il suspence thriller (Hounds of Love), il western (Pariente), il road-movie (The Road to Mandalay), senza dimenticare il dramma familiare declinato in chiave realista (La ragazza del mondo), grottesca (Quit Staring at My Plate), memoriale (Sami Blood). Dalla Siria alla Bolivia, dalla Svezia all’Asia, i grandi temi della politica e del disagio sociale corrono come vene scoperte o sotterranee in molti dei titoli della selezione; ma una volta di più è l’individuo singolo a combattere contro la crudezza del destino e della società. Segno di uno smarrimento senza facili soluzioni consolatorie che caratterizza questo momento delle nostre civiltà. Anche per questo contrasto drammatico e per la forza devastante di una realtà che non è mai semplice spettacolo, l’apertura delle Giornate 2016 è riservata all’emozionante video-diario dal cuore della Siria The War Show del danese Andreas Dalsgaard e della siriana Obaidah Zytoon.
Gli eventi speciali, che quest’anno caratterizzeranno anche alcune delle serate alla Villa degli Autori, sono presentati fuori concorso per i temi, i motivi e il carattere che mettono in luce e che alimentano la riflessione e il dialogo tipici delle Giornate. Così è per la prima co-produzione ufficiale tra l’Italia e la Cina, Coffee di Cristiano Bortone, a completare una serie di iniziative dedicate al dialogo tra le due culture che prosegue anche quest’anno con la terza edizione del China Film Forum; così è per i dialoghi sulla fede, l’accoglienza, l’umanità che accomunano le riflessioni di due artisti molto diversi come Giorgio Pressburger (Il profumo del tempo delle favole) e Pippo Delbono presente alle Giornate come attore (La ragazza del mondo) e regista/narratore nel suo provocatorio Vangelo. Così è per i ritratti di due icone della trasgressione come Rocco e You Never Had It, conversazione venuta dal passato con lo “scandaloso” Charles Bukowski.
La serie degli eventi speciali si completa con il gemellaggio con il Tribeca Film Festival che ogni anno porta alle Giornate uno dei suoi titoli statunitensi in anteprima internazionale (Always Shine di Sophia Takal), i film brevi della serie Women’s Tales firmati quest’anno da due autrici come Naomi Kawase e Crystal Moselle, un film-sorpresa che verrà annunciato in seguito così come il film di chiusura dell’edizione 2016.
Molti i partner che anche quest’anno affiancano e arricchiscono l’attività delle Giornate degli Autori: la SIAE che assegnerà il Premio alla Carriera e una Speciale Menzione a uno dei titoli italiani della selezione; le associazioni degli autori (Anac e 100autori) che animeranno le giornate di approfondimento tematico; Miu Miu con la serie di conversazioni sulla creatività femminile; Bridging the Dragon che collabora al China Film Forum insieme a Doc/it che porterà a Venezia la sua attività a sostegno del cinema del reale; i media partner Cinecittà News, Cineuropa e Fred, il Premio LUX che porta a Venezia i tre titoli finalisti dell’anno; la Trentino Film Commission, Sub-ti.
Le Giornate degli Autori sono realizzate in accordo con La Biennale di Venezia.
«Mitica, seducente, mutante, inquietante è quest’anno la Sirena – dice Giorgio Gosetti -, l’immagine simbolo della XIII edizione: un omaggio alla femminilità e al mare che di Venezia sono l’origine; ma anche a quella dimensione inafferrabile e unica che è dell’arte e dell’invenzione umana. Noi non siamo sirene, ma per la loro sopravvivenza ci battiamo».

SELEZIONE UFFICIALE
FILM DI APERTURA – IN CONCORSO
THE WAR SHOW di Andreas Dalsgaard e Obaidah Zytoon
Danimarca / Finlandia, 2016, prima mondiale
Produzione: Fridthjof Film in co-produzione con Oktober Oy, Dharma Film
Vendite internazionali: DR Sales by Kim Christiansen
Obaidah e un gruppo di amici partono da Damasco per un viaggio attraverso la Siria per prendere parte alla rivoluzione. Sarà un’esperienza destinata a cambiare le loro vite perché saranno testimoni della spirale che ha portato il paese alla guerra civile. Il materiale girato appartiene in gran parte al gruppo di amici che si vedono sullo schermo, specialmente Dana e Obaidah che cominciarono a girarlo nel 2011.
Obaidah Zytoon ha vissuto in Turchia fino al 2014. Vive in Danimarca dal dicembre 2015 ma poiché non ha voluto fare richiesta di asilo politico si trova in una situazione critica non potendo rientrare né in Turchia né nel suo paese. Forse andrà in Libano dove oggi vivono i suoi genitori.
Andreas Dalsgaard è stato coinvolto nel progetto dalla produzione Fridthjof nel giugno 2014 dopo che una serie di contrasti tra il team danese e i protagonisti siriani avevano bloccato la lavorazione del film. Con lui hanno lavorato al montaggio finale il celebre montatore Adam Nielsen e il Ceasar Groep per le immagini fotografiche.
La rabbia, la rivolta, la guerra civile: nel cuore dell’inferno siriano raccontato senza sensazionalismi, quasi un video-diario cominciato nel 2011 e vissuto come un road movie molto personale in cui si stagliano personaggi tanto epici quanto reali. La guerra non è uno spettacolo, è sangue, speranze, sofferenze e delusioni.
CONCORSO
HJARTASTEINN (HEARTSTONE) di Guðmundur Arnar Guðmundsson
Opera prima
Islanda / Danimarca, 2016, prima mondiale
Con: Søren Malling, Baldur Einarsson, Blær Hinriksson, Diljá Valsdóttir
Produzione: SF Studios Production ApS, Join Motion Pictures
Vendite internazionali: Films Boutique
In un piccolo villaggio di pescatori gli adolescenti Thor e Christian vivono un’estate turbolenta: mentre il primo cerca di conquistare il cuore di una ragazza, l’altro scopre nuove emozioni nella complicità tra maschi. Quando l’estate finisce e l’aspra natura dell’Islanda riprende il sopravvento viene il tempo di lasciare il mondo dei giochi per affrontare la brutalità dell’età adulta.
Ciò che ha fatto improvvisamente grande e appassionante il nuovo cinema islandese è il vibrante confronto tra l’uomo e la natura. Ma questo racconto tra due stagioni e due amori è anche un viaggio nel mito.
HOUNDS OF LOVE di Ben Young
Opera prima
Australia, 2016, prima mondiale
Con: Emma Booth, Ashleigh Cummings, Stephen Curry, Susie Porter
Produzione: Factor 30 Films
Vendite internazionali: Urban Distribution Intl.
La diciassettenne Vicki Malonie si imbatte in una coppia di pericolosi maniaci che la rapiscono in una strada di periferia. Osservando le dinamiche del rapporto che lega i suoi torturatori, Vicki capisce presto che, per poter restare viva, dovrà far leva su un possibile punto di rottura tra i due…
Sulla scena australiana degli anni ‘80, il più teso e nevropatico dei thriller diventa un ring claustrofobico per una partita a tre contro la morte. Ma ben presto le regole del gioco si alterano per sviluppi imprevedibili.
INDIVISIBILI (INDIVISIBLE) di Edoardo De Angelis
Italia, 2016, prima mondiale
Con: Angela Fontana, Marianna Fontana, Antonia Truppo, Tony Laudadio, Antonio Pennarella, Peppe Servillo, Gaetano Bruno
Produzione: Tramp in co-produzione con O’ Groove, con il contributo del MiBACT
Vendite internazionali: True Colours
Distribuzione italiana: Medusa Film
Due gemelle siamesi cantanti, grazie alle loro esibizioni, danno da vivere a tutta la famiglia. Le cose vanno bene fino a quando non scoprono di potersi dividere…
In un territorio tanto realista quanto onirico, in un litorale campano che raccoglie un universo visionario ed estremo nasce la strana favola di Viola e Dasy, indivisibili, sognatrici, disperate e felici. La conferma di un autore che rinnova il cinema italiano.
NE GLEDAJ MI U PIJAT (QUIT STARING AT MY PLATE) di Hana Jušić
Opera prima
Croazia / Danimarca, 2016, prima mondiale
Con: Mia Petričević, Nikša Butijer, Arijana Čulina, Zlatko Burić
Produzione: Kinorama
Vendite internazionali: New Europe Film Sales
Tutta la vita di Marjana ruota intorno alla sua famiglia, che lo voglia o no. Vivono stipati in un piccolo appartamento e rischiano di andare fuori di testa finché un ictus che trasforma il padre in un vegetale costringe la ragazza a farsi carico dei superstiti: una madre onnipresente e un fratello handicappato. Marjiana adesso fa due lavori, cerca una boccata d’ossigeno in fuggevoli rapporti erotici con estranei, assapora il gusto della libertà. Ma cosa fare di se stessa una volta assaggiata la nuova condizione?
Si potrebbe dirlo con Hana Juŝić: «Lo stile del mio film oscilla fra il grottesco di Rabelais e il realismo psicologico dei miei personaggi che sono animali strani, ma anche capaci di profondità interiore e di drammi reali». Un esordio che non si dimentica.
PAMILYA ORDINARYO di Eduardo Roy, Jr.
Filippine, 2016, prima internazionale
Con: Ronwaldo Martin, Hasmine Killip, Maria Isabel Lopez, Sue Prado, Ruby Ruiz
Produzione : Found Films in coproduzione con Cinemalaya Foundation
Vendite internazionali: Ignatius Films
È il ritratto di famiglia di Jane, 16 anni, e del suo ragazzo, Aries, che vivono da soli nelle caotiche strade di Manila. Sopravvivono con piccoli furti ed espedienti ma la loro esistenza cambia quando si scoprono, senza preavviso, genitori. Appena un mese dopo la nascita, il loro bambino viene rubato. Nell’intento di riaverlo, i due smarriti genitori devono adottare misure estreme…
L’autore di Baby Factory e Quick Change, visto alla Berlinale del 2013, ritorna con un dramma “sulla strada” che sorprende per il punto di vista insolito e conferma che il nuovo cinema di Manila non si ferma dalle parti di Lav Diaz e Brillante Mendoza.
PARIENTE (GUILTY MEN) di Iván D. Gaona
Opera prima
Colombia, 2016, prima mondiale
Con: Willington Duarte, René Calderón, Leidy Herrera Castillo, Christian Hernández, Alfonso López
Produzione: La Banda del Carro Rojo, con il supporto di Proimágenes Colombia e Fondo Cinematográfico
Mancano otto giorni al matrimonio tra Mariana e René, il cugino di Willington che ama la donna in segreto. Non avendo i soldi per il matrimonio, René decide di rubarli. Nella regione si sta ufficialmente sciogliendo un gruppo illegale di vigilantes, ma una serie di morti sospette getta una luce sinistra anche sulle nozze imminenti. Così il futuro di René finirà, per uno scherzo del destino, a dipendere da Willington.
Western rurale e contemporaneo, una ballata degna di Sam Peckimpah, una storia di vendette private che ha sullo sfondo il disastro di un paese e di una società corrotta dal sogno della ricchezza e dalla brutalità politica.
POLINA, DANSER SA VIE (POLINA) di Valérie Muller e Angelin Preljocaj
Opera prima
Francia, 2016, prima mondiale
Con: Nastya Shevtzoda, Aleksey Guskov, Juliette Binoche, Niels Schneider
Produzione: Everybody On Deck
Vendite internazionali: TF1 International
Nella Mosca dei primi anni ‘90, quando la cortina di ferro è appena caduta, una bambina di otto anni scopre le sue incredibili doti di ballerina grazie alla severa scuola del maestro Bojinski che la preparerà per il Teatro Bolshoi. Dieci anni dopo la giovanissima allieva incontra l’amore e l’ispirazione grazie al francese Adrien, un suo coetaneo che la porterà ad Aix-en-Provence dove Polina apprende i segreti della danza moderna. La sua parabola si compirà però tra Anversa, Montpellier, Avignone quando Polina sarà ormai diventata una donna.
Danzare la vita non significa poter superare di slancio la paura, la durezza, la solitudine. Nel tragitto della bambina Polina, della giovane étoile, della donna che scopre se stessa lontano dal progetto che il destino sembra assegnarle, uno dei più grandi coreografi del mondo, insieme a sua moglie Valérie, firma un esordio che va ben oltre la danza. Ispirato alla graphic novel di Bastien Vives, «il viaggio di Polina – dicono gli autori – è tanto un’avventura fisica ed emotiva quanto un percorso di crescita artistica».
LA RAGAZZA DEL MONDO (WORDLY GIRL) di Marco Danieli
Opera prima
Italia, 2016, prima mondiale
Con: Sara Serraiocco, Michele Riondino, Marco Leonardi, Stefania Montorsi, Lucia Mascino, Pippo Delbono
Produzione: CSC Production, Rai Cinema in co-produzione con Barbary Films
Vendite internazionali: Intramovies
Distribuzione italiana: Bolero Film
Quello di Giulia è un mondo antico e sospeso, fatto di rigore e testi sacri, che esclude con ferocia chi non vi appartiene. Quello di Libero è il mondo di tutti gli altri, di chi sbaglia, di chi si arrangia cercando un’altra possibilità e di chi ama senza condizioni. Quando Giulia incontra Libero scopre di poter avere un altro destino, tutto da scegliere. La loro è una storia d’amore purissima e inevitabile e per i due ragazzi inizia un intenso periodo di vita insieme, scelta che comporterà per Giulia una totale esclusione dal mondo dei Testimoni di Geova al quale appartiene.
Quella dei Testimoni di Geova in Italia è un delle comunità più fiorenti e significative d’Europa. Il film d’esordio dell’ex allievo e ora docente del CSC Marco Danieli (classe 1976) non vuole però proporsi come un documento su questo mondo; piuttosto un confronto fra due idee di libertà e felicità che stringono Giulia fino quasi a stritolarla.
SAMEBLOD (SAMI BLOOD) di Amanda Kernell
Opera prima
Svezia / Danimarca / Norvegia, 2016, prima mondiale
Con: Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok, Maj Doris Rimpi
Produzione: Nordisk Film Production Sverige in co-produzione con Sveriges Television, Bautafilm, Digipilot,
Vendite internazionali: LevelK
A 14 anni Elle Marja è una ragazzina innocente della comunità Sami, i “nativi” dell’estremo nord svedese. Esposta al razzismo coloniale degli anni ‘30 e alla certificazione della razza a cui è sottoposta a scuola, la ragazza sogna una vita diversa in cui non doversi sentire ogni volta ‘diversa’. Per ottenerla dovrà però tagliare ogni ponte con la sua famiglia, con la cultura della sua gente e diventare un’altra. Tanti anni dopo Elle Marja ritorna alla sua terra d’origine…
Lo Yoik è un ormai quasi dimenticato canto tradizionale del popolo Sami. «Questo film – dice la sua autrice – è una storia di canto e sangue, una dichiarazione d’amore per quelli che scapparono e per quelli che restarono durante una delle pagine più oscure del colonialismo svedese». Ma è anche un emozionante viaggio nell’idea stessa di identità culturale al tempo dell’omologazione globale.
ZAI JIAN WA CHENG (THE ROAD TO MANDALAY) di Midi Z
Myanmar / Taiwan Cina / Francia / Germania, 2016, prima mondiale
Con: Kai Ko, Wu Ke-Xi
Produzione: Seashore Image Productions, Flash Forward Entertainment, Myanmar Montage Films, House on Fire in co-produzione con Pop Pictures Company Limited, Bombay Berlin Film Production
Lianging e Guo si incontrano durante il loro passaggio clandestino attraverso il confine tra Burma e la Thailandia. Lianging trova lavoro come lavapiatti in città mentre lui finisce in una fabbrica di tessuti della periferia. Mentre la fiducia di Lianging nel suo cavalier servente viene pian piano meno, la fedeltà cieca di Guo non muta. Eppure il loro amore è ormai irrimediabilmente compromesso…
Il tema del viaggio, insieme a quello del femminile, caratterizza la selezione di quest’anno: viaggio come ricerca, movimento, simbolo del cambiamento, corsa ignara verso il vuoto. Midi Z si conferma uno dei più esplosivi talenti del cinema asiatico e porta alla ribalta una cinematografia – quella birmana – quasi sconosciuta in Occidente.
WOMEN’S TALES
#11 SEED di Naomi Kawase
Italia / Giappone, 2016
Con: Sakura Ando, Jiji Boo, Wakato Kanematsu
Produzione: Hi! Production
Una ragazza compie un viaggio, spostandosi dalla natura selvaggia di Nara alla folla e alle strade congestionate di Tokyo. Lungo il cammino, incontra un ragazzo che le fa dono di una mela. Lei la offrirà in seguito a un senzatetto, che ricambia con uno svolazzante tessuto di chiffon. Nel corso delle diverse trasformazioni, la ragazza si muove come un albero che ondeggia al vento, espressione di uno spirito che scorre segretamente in questi oggetti e luoghi diversi, pulsanti di vita.
Della protagonista interpretata da Sakura Ando, Naomi Kawase dice: «Sembra piuttosto una fata, una creatura misteriosa». La narrazione della storia cambia la nostra percezione. «Che succede se vediamo le cose capovolte?». Il suo è anche un ritratto pieno di sentimento della femminilità asiatica, che la regista definisce «primitiva, originaria ed erotica allo stesso tempo».
#12 THAT ONE DAY di Crystal Moselle
Italia / Stati Uniti, UK, 2016, Prima mondiale
Con: Rachelle Martinez, Nina Moran, Ardelia Lovelace, Ajani Russell, Jules Lorenzo, Brenn Lorenzo, Kabrina Adams, Amber Coffman
Produzione: Hi! Production !, Somesuch
In un solo giorno può cambiare tutto. Rachelle, una ragazza di 17 anni della periferia di New York, se ne rende conto durante un viaggio alla scoperta di se stessa a bordo del suo skateboard. Intimorita da un sessismo machista e indifferente, si imbatte per caso in una gang di skater, piene di carisma e senza paura, che le mostrano l’esistenza di un altro mondo. Un universo femminile fatto di amicizia, forza e senso di appartenenza.
Crystal Moselle è una regista americana che vive a New York, nota soprattutto per “The Wolfpack”, il documentario vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance 2015.
EVENTI SPECIALI
In accordo con il Tribeca Film Festival
ALWAYS SHINE di Sophia Takal
Stati Uniti, 2016, prima internazionale
Con: Davis Mackenzie, Caitlin Fitzgerald
Produzione: Little Teeth Pictures in associazione con Salem Street Entertainment
Vendite internazionali: Visit Films
Due attrici si mettono in viaggio verso Big Sur per curare la loro amicizia, ma la gelosia riapre antiche ferite. È il terreno di racconto ideale per un complicato e suggestivo thriller che ruota intorno a temi come ossessione, celebrità, femminilità.
CAFFÈ (COFFEE) di Cristiano Bortone
Italia / Belgio / Cina, 2016, prima mondiale
Con: Hishem Yacoubi, Arne De Tremerie, Koen De Bouw, Lu Fang-Sheng, Zhuo Tan, Sarah Li, Dario Aita, Miriam Dalmazio, Ennio Fantastichini
Produzione: Orisa Produzioni (Italia), Savage Film (Belgio), Road Pictures, China Blue Film (Cina) con il contributo del MIBACT, in collaborazione con Rai Cinema, D’Hive, Yunnan Communication Group, Lucent Pictures
Distribuzione italiana: Officine Ubu
I sommelier dicono che il caffè abbia tre sapori: l’amaro, l’aspro e una nota finale profumata. Attraverso l’elemento comune di questo prodotto così evocativo, il film racconta tre storie ambientate in tre parti del mondo molto lontane fra di loro, tre destini che si intrecciano nei tempi confusi e incerti che il nostro mondo sta vivendo.
IL PROFUMO DEL TEMPO DELLE FAVOLE di Mauro Caputo
Italia, 2016, prima mondiale
Dal testo omonimo di Giorgio Pressburger
Produzione Vox Produzioni, Istituto Luce Cinecittà
Distribuzione italiana e vendite internazionali: Istituto Luce – Cinecittà
Trieste, città di confine e simbolo dell’unione cosmopolita, dove convivono persone di culture e nazionalità diverse, che hanno mantenuto vive le proprie tradizioni nei luoghi di culto, come i nove cimiteri appartenenti a diverse religioni. In questo contesto e in questi luoghi, Giorgio Pressburger cerca, tra dubbi e tormenti, i segni della propria fede, mettendo a nudo la sua esperienza, scardinando certezze e false ipocrisie, entrando nelle pieghe più nascoste della mente umana.
Il film verrà presentato nella cornice di una serata multimediale alla Villa degli Autori
ROCCO di Thierry Demaiziere e Alban Teurlai
Francia, 2016, prima mondiale
Produzione: Program 33, Mars Films, Falabracks
Vendite internazionali: Wild Bunch
Distribuzione italiana: BIM Distribuzione
Rocco Siffredi sta alla pornografia come Mike Tyson alla boxe, Mick Jagger al rock ‘n’ roll: una leggenda vivente. Oggi si racconta, a rischio di infrangere il mito; un “dietro le quinte” sul mondo del porno e delle sue stelle.
VANGELO di Pippo Delbono
Italia / Belgio, 2016, prima mondiale
Con: Pippo Delbono, Safi Zakria, Nosa Ugiagbe, nel ruolo di loro stessi e con l’amichevole partecipazione di Petra Magoni e Ilaria Fantin e con Bobò e Pepe Robledo
Produzione: Stemal Entertainment con Rai Cinema, in associazione con DO Consulting&Production, con Ventura Film, Snaporaxverein (Svizzera), Les films du fleuve (Belgio), in associazione con CDP e Arte France – La Lucarne, in collaborazione con Alce Nero
Pippo, regista teatrale, si reca in un centro dove i profughi trovano asilo e condivide la loro quotidianità fatta di tempo sospeso tra dolorose memorie e incerto futuro. Poco alla volta i rifugiati si aprono al regista, gli raccontano le loro storie. Qualcuna di queste sarà nel film, altre rimarranno segrete. E alla fine l’idea di mettere in scena il Vangelo prende una sua forma incarnandosi nelle vite di queste persone, inevitabili protagoniste di un tempo nuovo.
YOU NEVER HAD IT – AN EVENING WITH BUKOWSKI di Matteo Borgardt
Stati Uniti / Messico / Italia, 2016, prima mondiale
Con: Charles Bukowski, Silvia Bizio, Linda Lee Beighle, Frances Schoenberger, Michael Montfort, James Borgardt
Produzione: Alevi, Itaca Films
Vendite internazionali: Latam Pictures
Distribuzione italiana : Alevi
Questo breve documento nasce dalla video-intervista realizzata dalla giornalista italiana Silvia Bizio nel gennaio del 1981 con Charles Bukowski nella sua casa di San Pedro, California. E’ stata una lunga notte di sigarette e vino con lo scrittore e la sua futura moglie Linda Lee Beighle, a parlare di ogni possibile soggetto, dagli scrittori al sesso, dall’amore all’umanità. L’intervista fu registrata su nastri Umatic che poi rimasero dimenticati per oltre 30 anni; sono stati digitalizzati e editati con l’inserzione di nuove scene girate appositamente in Super8 e con alcune poesie lette dallo stesso Bukowski.
28 SGUARDI DALL’EUROPA. LA GIURIA DEL VENICE DAYS AWARD
Per il terzo anno consecutivo, il premio delle Giornate degli Autori Venice Days Award verrà assegnato da una giuria d’eccezione: i 28 giovani europei di 28 Times Cinema. Il progetto, che giunge quest’anno alla sua VII edizione, è promosso dalle Giornate degli Autori, dal LUX Film Prize del Parlamento europeo e dal network di sale d’essai di Europa Cinemas, con la collaborazione di Cineuropa.
28 Times Cinema è nato nel 2010 dall’esigenza di coinvolgere e interrogare le nuove generazioni, percepite sempre più lontane dalla sala cinematografica e in generale dal cinema d’essai. In questi anni 28 ragazzi tra i 18 e i 25 anni, ciascuno proveniente da un paese dell’Unione europea, sono stati invitati a Venezia per osservare da vicino il festival più antico d’Europa, arricchendolo con uno sguardo originale. Questa esperienza continua a dimostrare ogni anno l’interesse dei più giovani per il cinema indipendente, europeo e non. Il ventiquattrenne olandese Matthijs van der Veer non ha dubbi in proposito: «Il cinema d’essai soffre di una stigmatizzazione di prodotto vecchio e noioso. Riportarlo al centro della scena è il primo passo per riportarlo verso il pubblico».
La curiosità verso il nuovo anima da sempre i dibattiti che si svolgono alla Villa degli Autori. Per tenere unite le fila di una giuria così numerosa e varia, le Giornate degli Autori hanno preso in prestito il direttore artistico del Festival di Karlovy Vary, Karel Och, nel ruolo di coordinatore. «Non vedere l’ora di venire alla Mostra del Cinema significa per me non vedere l’ora di passare tempo con un gruppo di giovani appassionati di arte cinematografica le cui genuine opinioni sui film sono una boccata d’aria fresca insieme ad un raro arricchimento».
Per 15 giorni, 17 ragazze e 11 ragazzi provenienti da tutt’Europa e accomunati solo dalla passione per il cinema, si confronteranno su 11 film in concorso per il Venice Days Award, nonché sui temi di maggiore attualità nella scena cinematografica europea. Si tratterà di un gruppo assolutamente eterogeneo che conta al suo interno molti ragazzi appena usciti da scuola, studenti universitari di cinema e di animazione, giornalisti, blogger (quello di Adrià Guxens Chaparro vanta 400.000 lettori) musicisti, attori, ma anche storici, ingegneri e tuttofare come il ceco Jakub Brych: di giorno commesso e lavapiatti, di notte proiezionista. Alcuni di loro sono già inseriti nel mondo dei cinema: Mónika Bajnóczi (Ungheria) lavora da due anni come assistente editoriale con FIPRESCI, Elvire Munoz (Francia) firma sceneggiature per la TV belga, Maj Rafferty (Danimarca) dirige e produce video musicali anche per grandi produzioni scandinave, Carla Fotea (Romania) lavora nella casa di produzione fondata da Cristian Mungiu, Steven Armour (UK) cura il programma di corti a tema LGBT in uno dei principali cinema di Edimburgo mentre la svedese Clara Gower gestisce insieme ad altri tre volontari l’intera programmazione dell’unico cinema d’essai della sua città.
Da questo incrocio di passioni, culture, professioni e lingue diverse nascerà il verdetto decisivo che sancirà il vincitore della XIII edizione delle Giornate degli Autori.
 Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder e Deborah Snyder, con Richard Suckle, Stephen Jones, Wesley Coller, Geoff Johns, Connie Nielsen e Rebecca Roven come executive producers.
Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder e Deborah Snyder, con Richard Suckle, Stephen Jones, Wesley Coller, Geoff Johns, Connie Nielsen e Rebecca Roven come executive producers.


 Nel cast del film al fianco del protagonista
Nel cast del film al fianco del protagonista 
 Nel realizzare il remake del film del 1984 di Ivan Reitman, Feig ha dichiarato di voler adottare un tono spaventoso e allo stesso tempo comico, che però non abbia nessuna soluzione di continuità con il sequel del film del 1989, nè con la serie animata The Real Ghostbusters.
Nel realizzare il remake del film del 1984 di Ivan Reitman, Feig ha dichiarato di voler adottare un tono spaventoso e allo stesso tempo comico, che però non abbia nessuna soluzione di continuità con il sequel del film del 1989, nè con la serie animata The Real Ghostbusters.
 Presentato in apertura alla 62^ edizione del Taormina Film Fest e alla 46^ edizione di Giffoni Experience, Alla Ricerca di Dory ha già conquistato il record per il miglior debutto al box office per un lungometraggio d’animazione nelle sale americane. Diretto da Andrew Stanton (Alla Ricerca di Nemo, WALL•E), co-diretto da Angus MacLane (Toy Story of Terror!) e prodotto da Lindsey Collins (co-produttrice di WALL•E), la nuova avventura Disney•Pixar arriverà nelle sale preceduto dal cortometraggio Piper.
Presentato in apertura alla 62^ edizione del Taormina Film Fest e alla 46^ edizione di Giffoni Experience, Alla Ricerca di Dory ha già conquistato il record per il miglior debutto al box office per un lungometraggio d’animazione nelle sale americane. Diretto da Andrew Stanton (Alla Ricerca di Nemo, WALL•E), co-diretto da Angus MacLane (Toy Story of Terror!) e prodotto da Lindsey Collins (co-produttrice di WALL•E), la nuova avventura Disney•Pixar arriverà nelle sale preceduto dal cortometraggio Piper.
 Nel terzo capitolo del franchise fantascientifico ritorneranno Chris Pine e
Nel terzo capitolo del franchise fantascientifico ritorneranno Chris Pine e 




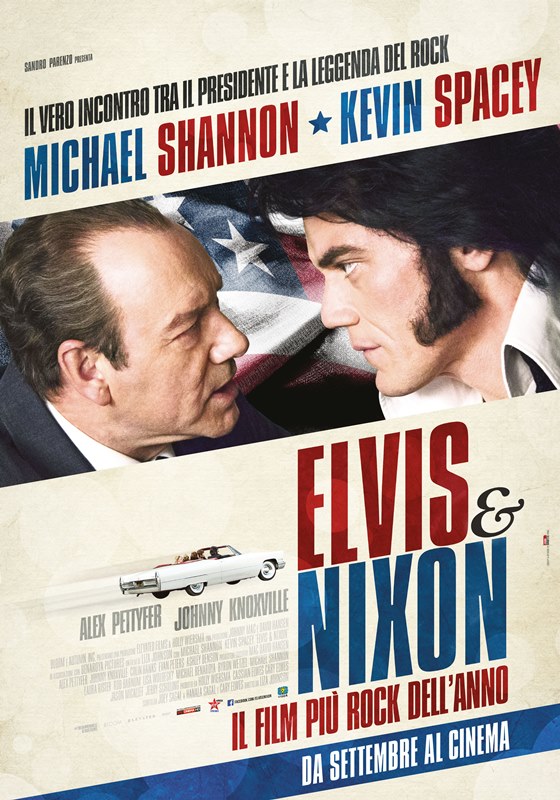
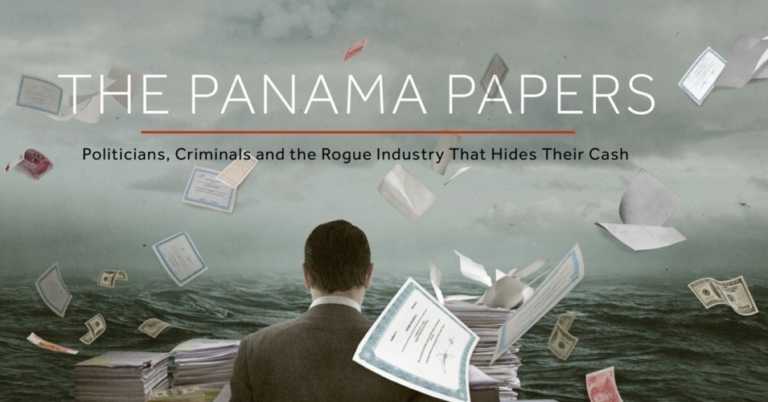

 Sezione autonoma e indipendente nel quadro della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, conosciute nel mondo con il brand internazionale di Venice Days, le Giornate sono ormai una realtà strutturale nel più antico festival cinematografico del mondo ma, da sempre, affiancano alla selezione del cinema indipendente di qualità una fitta attività di ricerca, incontri e dibattiti che hanno il loro fulcro nella Villa degli Autori.
Sezione autonoma e indipendente nel quadro della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, conosciute nel mondo con il brand internazionale di Venice Days, le Giornate sono ormai una realtà strutturale nel più antico festival cinematografico del mondo ma, da sempre, affiancano alla selezione del cinema indipendente di qualità una fitta attività di ricerca, incontri e dibattiti che hanno il loro fulcro nella Villa degli Autori.




 I dettagli dei personaggi per adesso sono ancora un mistero, ma si suppone che possano ricoprire i ruoli del resto della troupe del Covenant, che sarà comandata dal personaggio interpretato da
I dettagli dei personaggi per adesso sono ancora un mistero, ma si suppone che possano ricoprire i ruoli del resto della troupe del Covenant, che sarà comandata dal personaggio interpretato da 


 Lo abbiamo capito dalla clip “
Lo abbiamo capito dalla clip “ Il film arriverà al cinema il 13 agosto del 2016. Nel cast vedremo
Il film arriverà al cinema il 13 agosto del 2016. Nel cast vedremo 
 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures e Paramount Pictures, divisione della Viacom, Inc., annunciano oggi l’inizio delle riprese di “BEN-HUR” con Jack Huston (“AMERICAN HUSTLE – L’APPARENZA INGANNA”) nel ruolo di Giuda Ben-Hur,
Metro-Goldwyn-Mayer Pictures e Paramount Pictures, divisione della Viacom, Inc., annunciano oggi l’inizio delle riprese di “BEN-HUR” con Jack Huston (“AMERICAN HUSTLE – L’APPARENZA INGANNA”) nel ruolo di Giuda Ben-Hur, 




 Qui vediamo uno screen da trailer di Justice League con l’elettricità che sprigiona dal movimento di Barry;
Qui vediamo uno screen da trailer di Justice League con l’elettricità che sprigiona dal movimento di Barry; Qui invece vediamo Boomerang di spalle nel trailer di Suicide Squad.
Qui invece vediamo Boomerang di spalle nel trailer di Suicide Squad.






 Diretto da
Diretto da 
 L’uscita di Doctor Strange è prevista per il 4 novembre 2016. Dirige Scott Derrickson da una sceneggiatura di Jon Aibel e Glenn Berger, rimaneggiata da Jon Spaihts. Nel cast del film al fianco del protagonista
L’uscita di Doctor Strange è prevista per il 4 novembre 2016. Dirige Scott Derrickson da una sceneggiatura di Jon Aibel e Glenn Berger, rimaneggiata da Jon Spaihts. Nel cast del film al fianco del protagonista 
 Oltre al nuovo e criticato logo ufficiale di Thor Ragnarok, non abbiamo scoperto quasi nulla di importante in merito al film di Taika Waititi all’ultimo
Oltre al nuovo e criticato logo ufficiale di Thor Ragnarok, non abbiamo scoperto quasi nulla di importante in merito al film di Taika Waititi all’ultimo  Thor Ragnarok sarà diretto da
Thor Ragnarok sarà diretto da 


 Quando al
Quando al 
