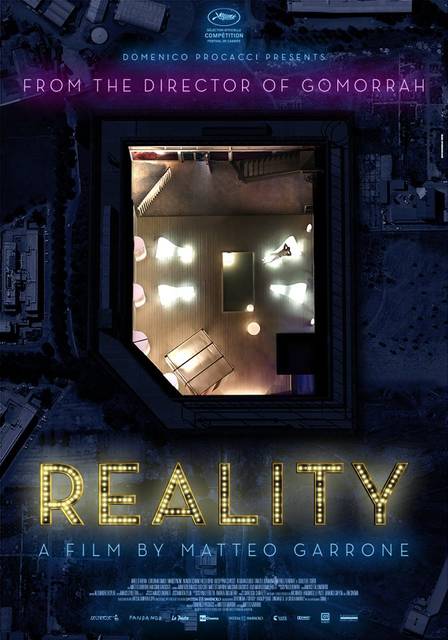Nell’Italia del ‘68/69 la contestazione studentesca è forte, gli operai sono in lotta. Si rivendicano diritti, si cerca un cambiamento che scuota anche il nostro paese dal torpore e dall’arretratezza, portando modernità. Le istituzioni vedono con allarme questi sommovimenti sociali. In questo clima, il 12 dicembre del ’69, l’esplosione a Piazza Fontana a Milano, alla Banca Nazionale dell’Agricoltura. 17 morti e più di 80 feriti. Tutto questo è Romanzo di una strage.
Su questo evento tragico della nostra storia, ancora non è stata fatta piena luce, e anzi si sono susseguite indagini, depistaggi, processi, affastellando dati e informazioni spesso in contraddizione tra loro. Marco Tullio Giordana raccoglie coraggiosamente questa sfida con Romanzo di una strage, film corale nel solco dell’esperienza del regista de La meglio gioventù, ma anche de I Cento Passi e Pasolini, un delitto italiano, con cui già aveva provato a far luce su alcune pagine oscure italiane. Si cimenta dunque nel tirare le fila di una vicenda intricata e di una stagione contraddistinta da altri eventi tragici rimasti senza una spiegazione definitiva. Vicenda intricata, ma sulla quale oggi, a distanza di 43 anni da quel ’69, abbiamo almeno un certo numero di dati accertati. Così parte il viaggio di ricostruzione del regista, coadiuvato dagli sceneggiatori Rulli e Petraglia, nonché da un cast di validissimi attori (Mastandrea, Favino, Gifuni, Lo Cascio, Antonutti, Colangeli, Tirabassi sono solo alcuni). Nel film appare molto evidente l’intento di chiarezza espositiva, esplicativo, ad uso delle giovani generazioni che non hanno vissuto quegli anni, ma hanno ereditato un mondo che ne portava il peso, e anche ad uso delle meno giovani, che a caldo non hanno potuto guardare ai fatti oggettivi e averne un panorama complessivo, come si è delineato poi negli anni.
In dieci capitoli e con un lavoro di scrittura certamente impegnativo, basato su atti processuali, inchieste giornalistiche e altro materiale, Giordana assieme agli sceneggiatori ricostruisce fatti e indagini, condotte dal commissario Luigi Calabresi/Valerio Mastandrea. Questi è inizialmente convinto che la pista da seguire sia quella anarchica, per questa strage come per altre bombe che da mesi mettono a rischio la città. Tra gli anarchici fermati, Giuseppe Pinelli/Pierfrancesco Favino, già noto a Calabresi come persona non violenta, ma da cui spera di ottenere informazioni importanti, in primis su Pietro Valpreda, l’anarchico che sarà poi arrestato, in base alla testimonianza del tassista Rolandi. Dopo tre giorni di fermo, la notte del 15 dicembre, Pinelli cade giù dalla finestra dell’ufficio di Calabresi, che non è presente nella stanza.
La versione ufficiale della Questura giustifica in modo maldestro l’accaduto, lasciando spazio al sospetto che Calabresi sia il diretto responsabile. Parte una campagna di stampa e d’opinione contro di lui. Nel frattempo, in Veneto, grazie al lavoro di due giudici, prende corpo un’altra pista, che vede in organizzazioni neonaziste e in particolare in Giovanni Ventura/Denis Fasolo e Franco Freda/Giorgio Marchese, gli autori di alcuni degli “attentati dimostrativi” dell’autunno. Ma su Piazza Fontana il panorama è ben più complesso: ci sono i depistaggi e la copertura di una parte dei servizi segreti italiani. Anche Calabresi, che continua ad indagare sulla strage, arriva a comprendere che vi sono legami, ancora oscuri, tra quest’eversione di destra e parti dello Stato, ma viene assassinato poco dopo.
A livello istituzionale più alto, poi, non mancano divisioni. I più cauti e lungimiranti di fronte ai torbidi scenari che si configurano dietro la strage, che vedono insieme movimenti eversivi di destra e pezzi deviati dello Stato, vorrebbero fare chiarezza, per eliminare macchie dalle istituzioni. Soprattutto Aldo Moro/Fabrizio Gifuni, allora Ministro degli Esteri. Altri invece, come il Presidente della Repubblica Saragat/Omero Antonutti, preferiscono nascondere le responsabilità a più alti livelli. Sarà alla fine questa la tesi che verrà seguita, e alla quale anche Moro si sottometterà, nella convinzione comune che il Paese non possa reggere la verità.

Romanzo di una strage, la verità esiste?
Se vi aspettate che il film risponda a tutti gli interrogativi, sarete in parte delusi. “La verità esiste”, come si legge sulla locandina, ed è un filo che c’è e che viene seguito per tutto il film, mettendo dei punti fermi dove è possibile, come si diceva in apertura, ma restano inevitabilmente aperte domande che il film ci pone e si pone, cimentandosi in ipotesi ricostruttive, sulla base però dei dati acclarati. È dunque un film aperto per molti aspetti. Giordana si espone e non teme di mettersi in gioco e prendere una posizione: descrive ad esempio in maniera precisa il rapporto tra Calabresi e Pinelli come cordiale e reciprocamente rispettoso e accredita la versione, suffragata dalle testimonianze, che il commissario non fosse nella stanza al momento della caduta di Pinelli.
Affida a Moro alcune delle battute più significative del film, come quelle del dialogo col confessore in apertura, o del colloquio con Saragat a ridosso del Natale ’69, in cui la sua visione pare molto presente nelle parole dell’allora ministro. Il regista dà poi anche una sua lettura più ampia, che vede in quella strage del ’69 il momento di rottura, quello in cui si è persa l’occasione per la nostra democrazia, nata da poco, di crescere, rafforzarsi e sperimentarsi liberamente. Quel tragico evento, ma soprattutto la mancata chiarezza, le ombre, l’opacità con cui l’intera vicenda e quelle ad essa legate sono state gestite da parte delle istituzioni, hanno creato una frattura estremamente difficile da ricomporre, tra cittadini e istituzioni. Tra i primi si è fatta largo la diffidenza nei confronti delle seconde, e ancora oggi il nostro sistema democratico paga le conseguenze di quelle scelte. Ecco dunque l’importanza di riesaminare quegli eventi, ora con maggiore serenità e obiettività.
Veniamo al punto di vista strettamente cinematografico. Qui, l’impressione è che si sia un po’ sacrificato alla chiarezza espositiva l’aspetto del coinvolgimento e dell’emozione. La divisione in capitoli, se da una parte è funzionale al primo aspetto, dall’altra interrompe la narrazione, spezzando il ritmo e allontanando lo spettatore. La ricchezza della materia trattata è poi certo una delle ragioni per cui non ci si è potuti soffermare a delineare in maniera molto complessa i personaggi. Si è scelto ad esempio di lasciare fuori quasi del tutto gli aspetti privati della vita di Calabresi e Pinelli, i personaggi a cui si dà più risalto nel film. Tuttavia, specie nel caso del commissario Calabresi, forse qualche elemento in più poteva essere aggiunto, anche per aiutare a capire meglio la sua figura, che invece resta per certi versi nebulosa, criptica.
Si è scelta una chiave interpretativa direi minimalista, a sottrarre, più adatta ad alcuni frangenti, ma che in altri non riesce a coinvolgere molto, nonostante la buona interpretazione di Valerio Mastandrea. In certi momenti cruciali, ad esempio la caduta di Pinelli o la successiva riunione in questura coi superiori, sembra strano che Calabresi non pronunci qualche parola in più. Il personaggio e la vicenda di Pinelli riescono invece comunque ad emergere bene, e ci regalano forse, assieme alla dolente consapevolezza dei gesti e delle parole di Moro, alcune delle parti più riuscite del film. Doverosa una menzione per l’ottimo Omero Antonutti nei panni di Saragat, ma come detto tutto il cast dà ottime prove. Tuttavia, il complesso della vicenda, non coinvolge fino in fondo, non conquista il cuore dello spettatore, non lo avvince del tutto, non fa venire la pelle d’oca o commuovere, come in altre occasioni le pellicole del regista, pur a confronto con vicende complesse, avevano saputo fare. Molto curate sono la fotografia, la scenografia, le musiche.
L’operazione era senz’altro ardua e va reso merito a Giordana e al cast di aver avuto grande coraggio nell’affrontare finalmente anche al cinema questa pagina buia della nostra storia, inaugurando speriamo, una nuova stagione di riflessione e chiarimento. E ricordandoci anche il nostro diritto a chiedere quella parte di verità che ancora manca. Non solo per rispetto nei confronti delle vittime e dei loro familiari, cui il film è dedicato, ma anche perché solo così, sembra dirci il regista, si potrà provare a ripartire dal punto in cui quell’esplosione ci ha interrotti. Romanzo di una strage sarà nelle sale dal 30 marzo.