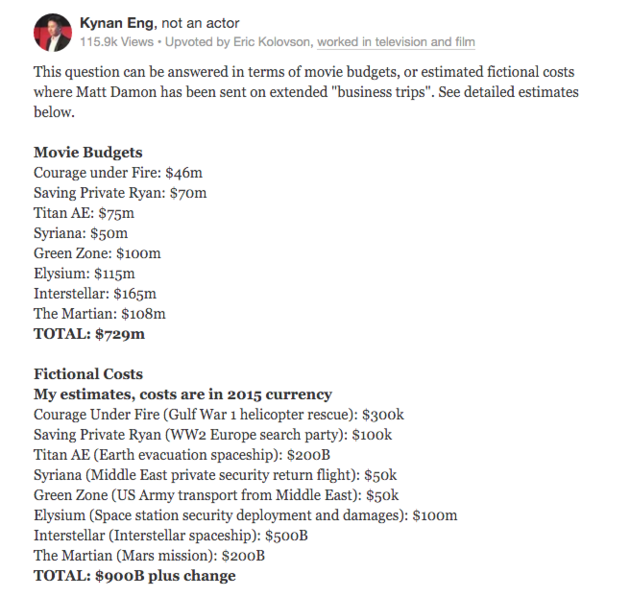Last Shift è il
film del 2014 diretto da Anthony DiBlasi con
Juliana Harkavy, Joshua Mikel, J. LaRose.
La trama di Last
Shift
Jessica Loren è un giovane agente
di polizia alla quale viene assegnato, come primo incarico, di
vigilare per un’intera nottata in una stazione di polizia in
procinto di essere chiusa l’indomani mattina, la stessa stazione
nella quale alcuni anni prima suo padre era stato brutalmente
massacrato assieme ad altri colleghi durante la rivolta di un
gruppo di detenuti affiliati ad un’oscura setta satanica. La ronda
notturna inizia senza particolari problemi ma ben presto cominciano
ad accadere alcuni strani avvenimenti, tra cui un misterioso
vagabondo che si presenta alla porta della centrale e inquietanti
apparizioni che fanno capire alla giovane Jessica di non essere del
tutto sola, come se qualcuno o qualcosa la stesse aspettando per
dare il via ad un terribile e irreale gioco al massacro.
L’analisi di Last Shift
A una prima confusa e distratta
visione Last Shift potrebbe sembrare
niente di più di un grottesco remake in chiave
ortorifico-soprannaturale del capolavoro di John Carpenter
Distretto 13 – Le brigate della morte, poiché le
suggestioni narrative paiono coincidere più che evidentemente: un
protagonista isolato nel mezzo nel nulla il quale può contare solo
sulla propria forza di volontà; una minaccia incombente (qui di
matrice dichiaratamente fantasmatica) che vuole scardinare un
precario equilibrio; un’atmosfera da trincea in assedio degna di
uno dei migliori war movies di sempre.
Ebbene, espletate le più che
necessarie chiarificazione riguardo l’indubbio debito
metacinematografico della pellicola di Anthony
DiBlasi dal masterpiece carpenteriano va
oltremodo appuntato che, da qui in avanti, il racconto procede
sulle proprie solide e ben piantate quattro zampe, delineando una
narrazione tesa e ben congeniata nella quale si mescolano numerose
suggestioni provenienti da ben altri pozzi di genere, tra le quali
vanno segnalate le reminiscenze esoterico-sataniche di
Sinister (2013) (tra
cui spicca la ripresa del dispositivo filmico come portale di
accesso del mondo demoniaco) così come le più nobili strizzate
d’occhio alle inquietanti apparizioni di Il sesto
senso (1999).
La grande venerazione di DiBlasi
per l’universo mostruoso e cabalistico di Clive
Baker, ottimamente dimostrato in quel piccolo gioiellino
di Dread (2012) e con
esiti molto meno felici nel pessimo Cassadaga
(2011), si fonde qui con l’imprinting di un ghost
movie che unisce alle canoniche apparizioni ectoplasmatiche in
salsa psicopatica (il tòpos dell’impossibilità di
distinguere fra sogno e realtà in stile
Gotika) la formula basica dello
slasher che prevede la concentrazione degli eventi in un
unico luogo claustrofobico dove avviene la mattanza, in una forma
perversa e postmoderna del celebre kammerspiel tedesco
infarcito di gore all’ennesima potenza.
Qui in realtà molti di questi
dettami classici vengono disattesi, iniziando dall’ambientazione in
interni della stazione di polizia, perennemente abbagliata da una
fredda e asettica luce al neon che fa risaltare il bianco perlato
delle pareti, così come la presenza di una un’unica protagonista
che si trova a dover gestire da sola l’intera schiera di oscure
presenze scaturite da un passato tutt’altro che remoto e pronte a
ghermirla nei suoi incubi più che nella vita reale (come a dire,
meno Jason e più Freddy Kruger).
Ma è proprio questo uso
anticonvenzionale dei canoni figurativi del cinema di tensione che
accresce ulteriormente la natura inquietante della narrazione, in
particolare se si tiene a mente la nutrita schiera di riferimenti
nonsense e piccoli dettagli, spesso insignificanti ma
indubbiamente disturbanti, che vengono disseminati progressivamente
nel coso della vicenda e che delineano per tutti gli ottantasette
minuti del girato un’atmosfera malsana che cresce come nebbia e si
deposita su ogni inquadratura, ritardando sapientemente
l’escalation di terrore finale e preferendo puntare su una lenta e
inesorabile discesa nell’incubo.
Un lercio senzatetto dall’aspetto
tutt’altro che rassicurante si presenta alla porta della centrale
senza dire una parola, urinando sul pavimento per poi esplodere in
un’improvvisa ondata di aggressività subito sedata dalla
sconcertata Jessica. Una serie di telefonate di richiesta di
soccorso giungono alla centrale malgrado la linea sia già stata
deviata e tutte riportano la voce allarmata di una ragazza che
afferma di essere stata rapita.
Strane e criptiche scritte appaiono
sui muri accompagnate da televisori (un classico ormai!) che
mandano in onda stralci di interrogatori ai sadici membri di una
setta di adorazione del demonio. Voci e sussurri riempiono ogni
angolo non toccato dall’abbacinante bagliore delle lampade
artificiali, rendendo il tutto più strano di quanto non sia. Tutti
ingredienti miscelati con sapiente perizia e pazienza, sorretti da
una serie di suggestioni che rinunciano alla presenza massiccia di
computer graphic (almeno per i primi tre quarti di film)
per lasciare al potere del silenzio il valore evocativo.
Interessante risulta il modo con
cui la discreta sceneggiatura di Scott Poiley
decide di trattare la componente demoniaca ed esoterica della
vicenda, partendo dall’idea di evocare l’orami triste tradizione,
per lo più tutta americana, delle sette di adorazione del maligno
che affondano le loro radici negli anni ’60 all’interno di celebri
confraternite “di sangue” sul modello dell’iconica Manson
Family, in questo caso infarcite con un patrimonio figurativo
che si estende dal demone Pazuzu de
L’Esorcista (1973) fino alla già citata
influenza ancestrale di
Sinister, reggendo bene la prova
della credibilità almeno fino a quando non viene il delicato
momento di mostrare ciò che fino ad ora era stato solo
suggerito.
Se da una parte risultano molto
riuscite e felici alcune trovate visive che possono essere
rintracciate in
The Gallows (2015), dall’altra la messa in
scena delle apparizioni demoniche e della lotta fra Bene e Male
finisce forse per cadere troppo nel ridicolo, eccezion fatta per
l’ottimo finale che non si risparmia una dose di inventiva e di
sorpresa davvero lodevole.
Juliana Harkavy,
reduce dalle ottime comparsate televisive in
Graceland e
The Walking Dead, potendo inoltre
contare su una discreta carriera cinematografica alle spalle, regge
praticamente da sola l’intero coso della pellicola, dimostrandosi
più che dignitosa e capace nel dare corpo ai turbamenti e alle
terribili vicissitudini affrontate da una coraggiosa poliziotta che
si trova a vivere un inaspettato battesimo del fuoco in puro stile
luciferino, dovendo affrontare tutta da sola le leggi di un mondo
sovrannaturale che non accettano né prigionieri né sconti di pena.
Le è la start e la final girl, lei è la
scream queen su cui o spettatore riversa le sue ansie e
speranze. Lei è l’unica con cui potersi identificare in qualche
modo. In alternativa ci sono pur sempre demoni e fantasmi!
Last Shift appare
a conti fatti come un dignitoso e interessante prodotto di genere,
sicuramente molto più serio, intelligente e curato di numerose
produzioni ad alto budget di questi ultimi tempi, un prodotto che,
seppur dovendosi confrontare con problemi fisiologici non
indifferenti, finisce tutto sommato per risultare più che discreto
e gradevole anche ai palati più raffinati e cultori
dell’horror puro. Una pellicola che sa bene i propri
limiti e ne fa una virtù soprattutto nel momento in cui si è
chiamati a delineare l’orrore e l’angoscia attraverso il
suggerito piuttosto che il detto, così come
l’hitchockiana memoria ci ha insegnato a suo tempo.



![Lauren Cohan covergirl per Shape [FOTO] Lauren Cohan covergirl per Shape [FOTO]](https://www.cinefilos.it/wp-content/uploads/2014/09/Lauren-Cohan-768x432.jpg)




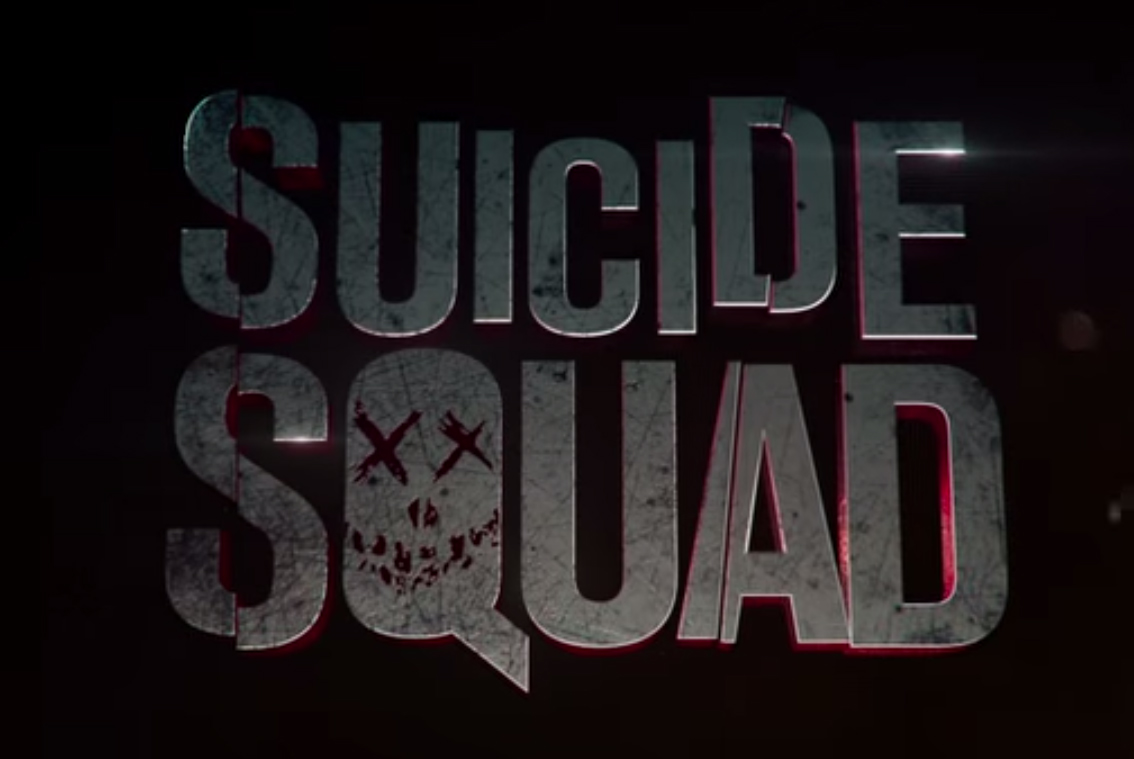
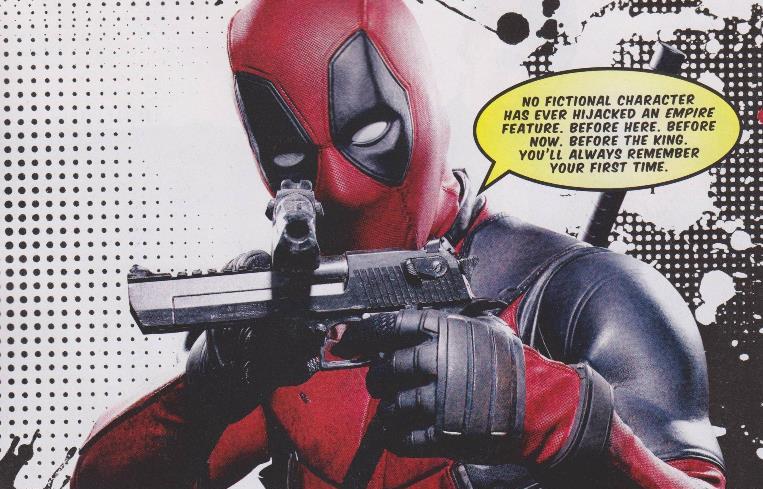
 Prima del film di Sam Raimi infatti
era James Cameron ad avere in cantiere un progetto
sull’Uomo Ragno in cui figuravano Leo, nei panni del protagonista,
e addirittura
Prima del film di Sam Raimi infatti
era James Cameron ad avere in cantiere un progetto
sull’Uomo Ragno in cui figuravano Leo, nei panni del protagonista,
e addirittura 

 C’è stato un periodo in cui
Amanda Seyfried era quasi in ogni film che veniva girato. Da Mean
Girls a Mamma Mia! a Dear John a Ted 2. Mentre ha dato fugaci
scorci del suo corpo nei film Alpha Dog e Chloe, si è mostrata in
tutta la sua nuda bellezza solo quando ha interpretato Linda
Lovelace nel biopic intitolato Lovelace.
C’è stato un periodo in cui
Amanda Seyfried era quasi in ogni film che veniva girato. Da Mean
Girls a Mamma Mia! a Dear John a Ted 2. Mentre ha dato fugaci
scorci del suo corpo nei film Alpha Dog e Chloe, si è mostrata in
tutta la sua nuda bellezza solo quando ha interpretato Linda
Lovelace nel biopic intitolato Lovelace. Nonostante un caso di
omonimia ingombrante, Twilight è anche un film drammatico del 1998,
con Paul Newman, Gene Hackman, Susan Sarandon e James Garner e
infine con Reese Witherspoon che per l’occasione si spoglia!
Nonostante un caso di
omonimia ingombrante, Twilight è anche un film drammatico del 1998,
con Paul Newman, Gene Hackman, Susan Sarandon e James Garner e
infine con Reese Witherspoon che per l’occasione si spoglia! Portia de Rossi è arrivata
per la prima volta all’attenzione dell’America grazie alla sua
partecipazione a Ally McBeal. Ha fatto il suo debutto come attrice
nel film Sirens, dove interpreta una delle tante muse artistiche di
Sam Neill e dove compare senza veli.
Portia de Rossi è arrivata
per la prima volta all’attenzione dell’America grazie alla sua
partecipazione a Ally McBeal. Ha fatto il suo debutto come attrice
nel film Sirens, dove interpreta una delle tante muse artistiche di
Sam Neill e dove compare senza veli. Molte persone probabilmente
identificano
Molte persone probabilmente
identificano  Considerando quanti uomini
stavano aspettando di vedere più di
Considerando quanti uomini
stavano aspettando di vedere più di  Helen Hunt fa l’attrice da
quando aveva otto anni. Nonostante la lunga carriera e il grande
numero di film, arriva al nudo integrale solo nel 2012, in The
Session, film per il quale ha ricevuto una nomination agli Oscar di
quell’anno.
Helen Hunt fa l’attrice da
quando aveva otto anni. Nonostante la lunga carriera e il grande
numero di film, arriva al nudo integrale solo nel 2012, in The
Session, film per il quale ha ricevuto una nomination agli Oscar di
quell’anno. Molti ricorderanno Meg
Ryan come “It Girl” in 101 commedie romantiche alla fine degli anni
’80. Che si trattasse di Billy Crystal in Harry ti presento Sally o
Tom Hanks in Insonnia d’amore o di C’è Posta per te, Ryan è stata
l’attrice preferita di cui innamorarsi sullo schermo. In un film
del 2003, In The Cut, Ryan, a 42 anni, si spoglia completamente per
la prima volta e il ruolo rimane, non solo per il full frontal, uno
dei suoi più memorabili.
Molti ricorderanno Meg
Ryan come “It Girl” in 101 commedie romantiche alla fine degli anni
’80. Che si trattasse di Billy Crystal in Harry ti presento Sally o
Tom Hanks in Insonnia d’amore o di C’è Posta per te, Ryan è stata
l’attrice preferita di cui innamorarsi sullo schermo. In un film
del 2003, In The Cut, Ryan, a 42 anni, si spoglia completamente per
la prima volta e il ruolo rimane, non solo per il full frontal, uno
dei suoi più memorabili. Nel 1985, quando i film di
Brat Pack, John Hughes e Teenage Hijinks erano tutti generi
popolari, Kelly Preston è entrata in azione, partecipando a tre
film consecutivi che non hanno richiesto i suoi vestiti. Erano 52
Pick-Up, Mischief e Secret Admirer.
Nel 1985, quando i film di
Brat Pack, John Hughes e Teenage Hijinks erano tutti generi
popolari, Kelly Preston è entrata in azione, partecipando a tre
film consecutivi che non hanno richiesto i suoi vestiti. Erano 52
Pick-Up, Mischief e Secret Admirer. Era l’ultima ragazza della
porta accanto che mescolava carineria, ironico senso dell’umorismo,
intelligenza e quel po’ di carisma che ha fatto sì che ogni ragazzo
desiderasse uscire con lei e che le ragazze volessero essere lei.
Con film come Pretty in Pink e The Breakfast Club sul suo
curriculum, non avrebbe mai potuto facilmente lavorare una volta
diventata troppo grande per i ruoli da adolescente. Infatti la sua
carriera non ha avuto un grande successo dopo l’adolescenza. Ma,
nel 1995, è apparsa in topless per circa due secondi nel film
Malicious.
Era l’ultima ragazza della
porta accanto che mescolava carineria, ironico senso dell’umorismo,
intelligenza e quel po’ di carisma che ha fatto sì che ogni ragazzo
desiderasse uscire con lei e che le ragazze volessero essere lei.
Con film come Pretty in Pink e The Breakfast Club sul suo
curriculum, non avrebbe mai potuto facilmente lavorare una volta
diventata troppo grande per i ruoli da adolescente. Infatti la sua
carriera non ha avuto un grande successo dopo l’adolescenza. Ma,
nel 1995, è apparsa in topless per circa due secondi nel film
Malicious. Già apparsa brevemente nuda
in Shakespeare in Love, Gwyneth Paltrow si è
spogliata altre due volte. Prima a Sylvia dal 2003, dove ha
interpretato la poetessa tormentata Sylvia Plath. In Thanks For
Sharing del 2013, Paltrow apre la camicia mentre è alla finestra,
rivelando il suo seno a Joaquin Phoenix, che guarda dal basso.
Già apparsa brevemente nuda
in Shakespeare in Love, Gwyneth Paltrow si è
spogliata altre due volte. Prima a Sylvia dal 2003, dove ha
interpretato la poetessa tormentata Sylvia Plath. In Thanks For
Sharing del 2013, Paltrow apre la camicia mentre è alla finestra,
rivelando il suo seno a Joaquin Phoenix, che guarda dal basso.







 Tuttavia sembra davvero
assurdo fossilizzarsi sul suo aspetto fisico quando, in
Tuttavia sembra davvero
assurdo fossilizzarsi sul suo aspetto fisico quando, in