Il governo Renzi vuole mettere nuova benzina, nuovi soldi dentro il serbatoio dei nostri produttori indipendenti di film e fiction, che sono in riserva. E il carburante- insegnano i tedeschi, che hanno avuto l’idea per primi – può arrivare dalle aziende più effervescenti ma anche più privilegiate del Pianeta. A finanziare il nostro cinema e le nostre fiction saranno i giganti di Internet. Gente come Google, Amazon e Netflix (la tv via cavo attesa qui in Italia ad ottobre).
IL MODELLO TEDESCO
La parola magica – “tassa di scopo ” – è scritta nel documento sul “Rafforzamento del settore audiovisivo” che il ministro Franceschini e il sottosegretario Giacomelli hanno presentato alle nostre televisioni e alle associazioni dei produttori questo lunedì.
La Germania, dunque. In Germania, i giganti della Rete verseranno allo Stato una “fettina” del fatturato che realizzano nel Paese. Questi soldi saranno poi investiti (per il 70%) nella produzione di film e fiction tedesche, e nella loro distribuzione attraverso canali classici (la televisione, le sale cinematografiche). E per il 30% nella loro promozione in la Rete. “La Germania – ricorda il documento del governo Renzi – prevede introiti per 13 milioni l’anno”. Una cifra ragionevole che Google e compagnia – forti di un regime fiscale di favore in Europa – sopporterebbero come niente. Il modello tedesco attende il via libera della Commissione Ue per diventare operativo.
GLI AIUTI PUBBLICI
Ma la parolina “tassa di scopo” torna una seconda volta nel documento del nostro esecutivo. Lo Stato, ovvio, deve garantire dei contributi alla nostra industria dei sogni, del cinema e della fiction. Tra aiuti regionali, nazionali ed esenzioni fiscali, l’assegno è stato di 247,5 milioni nel 2014. Un quarto di quello garantito dai francesi.
Bene, il documento del governo spiega ora che le risorse pubbliche vanno “sganciate dalle legge annuale di bilancio”. Non ci sarà più un assegno fisso, per quanto misero. Si pensa semmai ad una “tassa di scopo”che graverebbe sull’intero comparto dell’audiovisivo. In Francia, dove l’imposta già esiste, capita ad esempio che le tv versino il 5,5% del loro fatturato per finanziare cinema e fiction. Esborso mitigato da un’Iva agevolata al 10%.
L’altra ipotesi, più probabile, è che l’assegno italiano sia legato “al gettito e all’Iva che il settore del cinema e dell’audiovisivo generano per l’erario”.
IL LOCALISMO
Il documento del governo descrive il momento di sofferenza delle nostre industrie. Che fatturano la metà delle cugine tedesche o inglesi; che esportano film meno “dei danesi o norvegesi”; e confezionano fiction “localistiche “, di quelle che piacciono solo a noi italiani.
Il sistema va ripensato, dunque, e ogni euro speso dovrà avere un senso (si promettono più risorse alla Mostra del Cinema e al Centro Sperimentale, molte meno a convegni e pubblicazioni inutili).
LA TELEVISIONE
E le televisioni? Per loro ci sono discreti sacrifici all’orizzonte. Le emittenti non potranno più sperare in deroghe ai loro obblighi di produzione e programmazione di opere indipendenti. Dovranno poi sfruttare il film che acquistano mettiamo entro 3 anni. Pena la perdita dei diritti (norma molto controversa). Dovranno proporre la fiction su tutte le piattaforme (dall’etere fino al web), pena la perdita dell’esclusiva (altra norma che farà discutere). Le super emittenti dovranno infine sottoporre al produttore dei contratti “standard “, pieni di clausole a garanzia dei piccoli soggetti che vendono la loro opera.
Repubblica









![Star Wars: i nuovi personaggi sui francobolli da collezione [foto] Star Wars: i nuovi personaggi sui francobolli da collezione [foto]](https://www.cinefilos.it/wp-content/uploads/2015/09/star-wars-stamps.jpg)







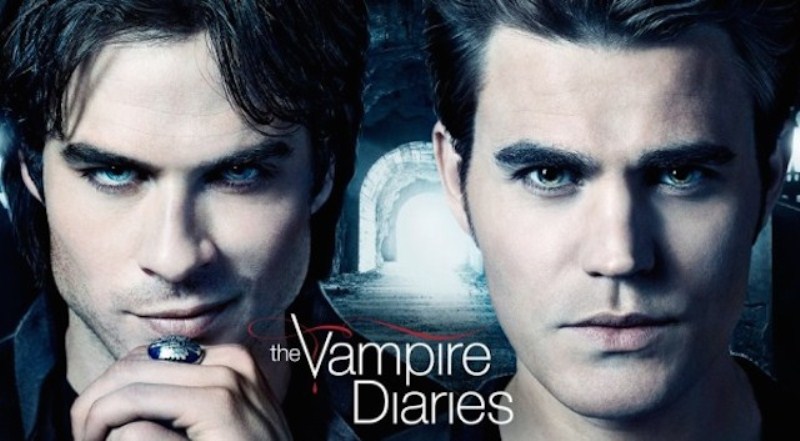









![Robert De Niro è Bernie Madoff in The Wizard of Lies [foto] Robert De Niro è Bernie Madoff in The Wizard of Lies [foto]](https://www.cinefilos.it/wp-content/uploads/2015/09/Robert-De-Niro.jpg)

