Tra i cinque mastodonti candidati all’ambito premio per la miglior regia ce n’è uno che risulta essere un Davide travestito da Golia. Stiamo parlando del giovane Benh Zeitlin che, a soli trent’anni con il suo primo lungometraggio Re della terra selvaggia (Beast of the southern wild) si trova a dover fronteggiare mostri sacri come Ang Lee, David O. Russell, Michael Haneke e Steven Spielberg.
E proprio Spielberg sembra destinato a dover lasciare andare questa statuetta in quello che era stato definito dalla critica come “l’anno di Spielberg” a fronte di una produzione colossale da 50 milioni di dollari per Lincoln, che si è guadagnato ben 12 nomination. Nomination più che meritate per una produzione lontana dai soliti canoni di Spielberg che è per lo più narrazione di una storia, lezione di politica e di grande cinema. La guerra civile da cui prende piede la vicenda è infatti solo lo spunto, mostrato all’inizio e alla fine della pellicola, per parlare del problema che il presidente più popolare degli Stati Uniti d’America si era trovato ad affrontare alla fine della guerra: la schiavitù. L’impresa registica, tentata e superata, costruita per la maggior parte in interni che necessitano di una visione d’insieme per poter restituire la giusta voce allo spettacolo messo in atto, è quella di rendere la politica una questione intima e personale, facendo di una caso di giustizia ed equità un’esperienza interiore imprescindibile da qualsiasi proclama elettorale.
L’incanto di una figura umana, troppo umana, deve però scontrarsi con quello delle immagini della cosmogonia di Ang Lee nel suo Vita di Pi. Già forte della statuetta per miglior regista conseguita sette anni fa con la struggente storia d’amore di Brokeback Mountain, il regista torna con tutt’altro genere, dando la luce a un racconto magniloquente e dai toni new. Meno criptico del regista statunitense, Lee prende parte all’adattamento de romanzo di Yan Martel dopo svariate turbolenze cominciate nel lontano 2003 che hanno visto il susseguirsi di svariati registi fino allo stop imposto al progetto nel 2010 per aver chiesto un budget troppo alto: 70 milioni di dollari. Lee ha dichiarato più volte di aver girato un film impossibile da girare che ha come co-protagonista una tigre scampata a un naufragio. Le atmosfere oniriche ed estremamente new age sono state agevolate da un uso sapiente del 3D, finalmente utilizzato in maniera funzionale alla narrazione della storia e non come semplice giustapposizione di qualche effetto in qualche scena. Un visionario racconto popolare, tenero e crudele allo stesso tempo che è riuscito a mettere d’accordo in maniera unanime la critica coniugando in modo eccellente realtà e computer grafica rischia di essere uno dei maggiori possibili candidati ad ambire la statuetta.
Tanto la bellezza delle immagini di Lee è elevata quanto cruda e spietata è la risposta in immagini alla domanda “Cos’è l’amore” che si pone l’austriaco Michael Haneke. Dopo il successo a Cannes con Il nastro bianco, il regista di Funny Games torna al cinema con Amour, bissa la Palma d’Oro sulla Croisette e si appresta minacciosamente a fare sua anche l’imminente notte degli Oscar con un film semplice, lineare e perfetto nel suo assetto narrativo. Amour è un knock out tecnico che avviene non appena il film comincia, dopo solo qualche scena, quando dei pompieri sfondano la porta di un appartamento borghese, corrono in camera da letto attirati dall’odore e la telecamera fa il resto: una donna stesa sul letto con dei fiori attorno, un momento di indugio per assimilare la scena, stacco e la comparsa del titolo del film bianco su sfondo nero che ne è anche la cifra stilistica: Amour. Un film sentimentale che non indugia sul sentimento ma che punta tutto sul racconto dell’amore visto come atto estremo.
Sullo stesso filone di Haneke si pone David O. Russel con la sua commedia amara Il lato positivo (Silver Linings Playbook) che porta in scena le vicende di due outsider, il protagonista Patrick che dopo otto mesi in un ospedale psichiatrico tenta di reinserirsi nella società non riuscendo però a dimenticare la sua ex moglie Nikki e la sua nuova fiamma Tiffany, altrettanto se non più problematica, rimasta vedova decisamente troppo presto. A colpire maggiormente è la toccante e umanissima delineazione psicologica dei due “scombinati” Patrick e Tiffany, coppia alle prese con i propri demoni personali che tenta tra mille errori di trovare un punto di connessione. Dopo la nomination avuta per The Fighter, Russel cambia genere raccontando la storia di due “scombinati” che cercano un qualche punto di raccordo tra loro e il resto del mondo, immersi in ambientazioni dimesse ma efficaci, scene costruite con dialoghi a volte assurdi e una regia incollata ai personaggi, vera forza di una pellicola che sebbene indulge verso una risoluzione facile della vicenda spicca per sensibilità dei temi toccati.
Probabilmente destinato ad avere meno chance di tutti di fronte alla rivelazione Benh Zeitlin che ha stupito e incantato il mondo imponendosi come rivelazione del 2012, vincendo inaspettatamente il Sundance Film Festival e uscendo trionfante dai principali eventi cinematografici internazionali fino a conquistarsi ben quattro nomination per l’ottantacinquesima notte degli Oscar tra cui quella per miglior regia. Sospeso tra poesia e realismo allucinato di Lucy Alibar, il racconto della dolce Hushpuppy, appartenente a una piccola comunità della Louisiana che vive con regole ai limiti della civiltà convenzionale e al di fuori della modernità, in una zona paludosa (“la vasca”) a continuo rischio uragani e inondazioni, è stato etichettato a ragione veduta come “il film che ha stupito il mondo” ponendosi come un vero e proprio gioiellino nell’attuale panorama cinematografico. Un tripudio di immagini investe del tutto lo spettatore, ammaliato da una bambina che ama ascoltare battere il cuore degli esseri viventi come prova dell’esistenza stessa. Un film dalla portata emotiva gigantesca, catalizzata tutta dalla piccola Hushpuppy, brutale e affascinante, proiettato in un tempo ipotetico che prende spunto da eventi reali per creare una personale mitologia della natura ribelle dell’animo umano.
Quest’anno la grande novità per l’Academy sarà proprio questa: dover scegliere tra passato e presente, tra convenzione e innovazione, tra grandi nomi e nuovi arrivati nel mondo del cinema. E il risultato potrebbe non essere poi così scontato, visto e considerato il precedente dell’anno scorso creato da Michel Hazanavicius con il suo film muto in bianco e nero The Artist.










 I personaggi, alle prese con profonde nevrosi, si liberano così come d’incanto da tutto il loro bagaglio di dolore e ritrovano la serenità grazie alla condivisione della reciproca compagnia. Il finale del film, per quanto romantico, rischia però di essere troppo semplicistico, di banalizzare la malattia mentale, vero e proprio gigante mostruoso da affrontare. Ma questa è stata probabilmente la scelta registica di voler realizzare una commedia, che nonostante le difficoltà vissute dai personaggi, riesce a condurli sani e salvi alla fine (o all’inizio?) della loro storia. Come al solito la regia di Russell segue i suoi personaggi, li pedina nei loro spostamenti esagerando talvolta con carrellate rapide che sembrano più adatta ad altri generi cinematografici.
I personaggi, alle prese con profonde nevrosi, si liberano così come d’incanto da tutto il loro bagaglio di dolore e ritrovano la serenità grazie alla condivisione della reciproca compagnia. Il finale del film, per quanto romantico, rischia però di essere troppo semplicistico, di banalizzare la malattia mentale, vero e proprio gigante mostruoso da affrontare. Ma questa è stata probabilmente la scelta registica di voler realizzare una commedia, che nonostante le difficoltà vissute dai personaggi, riesce a condurli sani e salvi alla fine (o all’inizio?) della loro storia. Come al solito la regia di Russell segue i suoi personaggi, li pedina nei loro spostamenti esagerando talvolta con carrellate rapide che sembrano più adatta ad altri generi cinematografici.








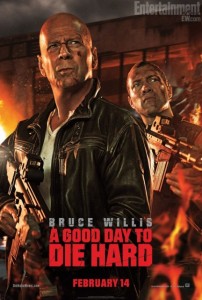



 Esordio col botto per
Esordio col botto per 



 Bill Nighy (“Harry Potter e i Doni della Morte”) nella parte del leader dei giganti, il Generale Fallon; ed
Bill Nighy (“Harry Potter e i Doni della Morte”) nella parte del leader dei giganti, il Generale Fallon; ed 



