 Si sono tenuti questa notte i Teen Choice Awards 2013 al Gibson Amphitheatre a Los Angeles. Oltre ai vincitori effettivi della manifestazione, come gli One Direction che hanno spopolato nelle categorie musicali, vera e propria vincitrice dell’evento è stata Lea Michele, alla sua prima apparizione dopo la morte del fidanzato e collega Corey Monteith.
Si sono tenuti questa notte i Teen Choice Awards 2013 al Gibson Amphitheatre a Los Angeles. Oltre ai vincitori effettivi della manifestazione, come gli One Direction che hanno spopolato nelle categorie musicali, vera e propria vincitrice dell’evento è stata Lea Michele, alla sua prima apparizione dopo la morte del fidanzato e collega Corey Monteith.
Ecco di seguito tutti i vincitori nella categoria cinema, televisione e musica:
MOVIES
Choice Movie: Action
“Iron Man 3”
Choice Movie Actor: Action
Robert Downey, Jr., “Iron Man 3”
Choice Movie Actress: Action
Anne Hathaway, “The Dark Knight Rises”
Choice Movie: Sci-Fi/Fantasy
“The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2”
Choice Movie Actor: Sci-Fi/Fantasy
Taylor Lautner, “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2”
Choice Movie Actress: Sci-Fi/Fantasy
Kristen Stewart, “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2”
Choice Movie: Drama
“The Perks of Being a Wallflower”
Choice Movie Actor: Drama
Logan Lerman, “The Perks of Being a Wallflower”
Choice Movie Actress: Drama
Emma Watson, “The Perks of Being a Wallflower”
Choice Movie: Comedy
“Pitch Perfect”
Choice Movie Actor: Comedy
Skylar Astin, “Pitch Perfect”
Choice Movie Actress: Comedy
Rebel Wilson, “Pitch Perfect”
Choice Movie: Romance
“The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2”
Choice Movie Actor: Romance
Robert Pattinson, “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2”
Choice Movie Actress: Romance
Kristen Stewart, “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2″
Choice Movie Villain
Adam DeVine, “Pitch Perfect”
Choice Movie Scene Stealer
Kellan Lutz, “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2”
Choice Movie Breakout Star
Nicholas Hoult, “Warm Bodies”
TELEVISION
Choice TV Show: Drama
“Pretty Little Liars”
Choice TV Actor: Drama
Ian Harding, “Pretty Little Liars”
Choice TV Actress: Drama
Troian Bellisario, “Pretty Little Liars”
Choice TV Show: Fantasy/Sci-Fi
“The Vampire Diaries”
Choice TV Actor: Fantasy/Sci-Fi
Ian Somerhalder, “The Vampire Diaries”
Choice TV Actress: Fantasy/Sci-Fi
Nina Dobrev, “The Vampire Diaries”
Choice TV Show: Action
“NCIS: Los Angeles”
Choice TV Actor: Action
LL Cool J, “NCIS: Los Angeles”
Choice TV Actress: Action
Lucy Liu, “Elementary”
Choice TV Show: Comedy
GLEE
Choice TV Actor: Comedy
Jim Parsons, “The Big Bang Theory”
Choice TV Actress: Comedy
Lea Michele, GLEE
Choice TV: Animated Show
THE Simpsons
Choice TV: Reality Competition Show
The X Factor
Choice TV: Reality Show
“Keeping Up with the Kardashians”
Choice TV Villain
Janel Parrish, “Pretty Little Liars”
Choice TV Personality – Male
Simon Cowell, The X Factor
Choice TV Personality – Female
Demi Lovato, The X Factor
Choice TV Female Reality Star
The Kardashians & Jenners, “Keeping Up with the Kardashians”
Choice TV Male Reality Star
Kevin Jonas, “Married to Jonas”
Choice TV Male Scene Stealer
Chord Overstreet, GLEE
Choice TV Female Scene Stealer
Miley Cyrus, “Two and a Half Men”
Choice TV Breakout Star
Blake Jenner, GLEE
Choice TV Breakout Show
“The Fosters”
MUSIC
Choice Male Artist
Justin Bieber
Choice Female Artist
Demi Lovato
Choice Music Group
One Direction
Choice R&B Artist
Bruno Mars
Choice Hip-Hop/Rap Artist
Macklemore & Ryan Lewis
Choice Rock Group
Paramore
Choice Electronic Dance Music (EDM) Artist
David Guetta
Choice Male Country Artist
Hunter Hayes
Choice Female Country Artist
Taylor Swift
Choice Country Group
Lady Antebellum
Choice Country Song
“We Are Never Ever Getting Back Together,” Taylor Swift
Choice Single: Female Artist
“Heart Attack,” Demi Lovato
Choice Single: Male Artist
“Beauty And A Beat,” Justin Bieber, featuring Nicki Minaj
Choice Single: Group
“Live While We’re Young,” One Direction
Choice R&B/Hip-Hop Song
“Can’t Hold Us,” Macklemore & Ryan Lewis, featuring Ray Dalton
Choice Rock Song
“Radioactive,” Imagine Dragons
Choice Love Song
“Little Things,” One Direction
Choice Break-Up Song
“Come and Get It,” Selena Gomez
Choice Music Breakout Artist
Ed Sheeran
Choice Music Breakout Group
Emblem3
FASHION
Choice Style Icon
Miley Cyrus
Choice Female Hottie
Selena Gomez
Choice Male Hottie
Harry Styles
Choice Smile
Harry Styles
SPORTS
Choice Female Athlete
Gabby Douglas
Choice Male Athlete
David Beckham
OTHER
Choice Comedian
Ellen DeGeneres
Choice Web Star
Cimorelli
Choice Social Network
Twitter
Candie’s Choice Style Icon
Demi Lovato
Choice Twitter Personality
Justin Bieber
Fonte: JustJared























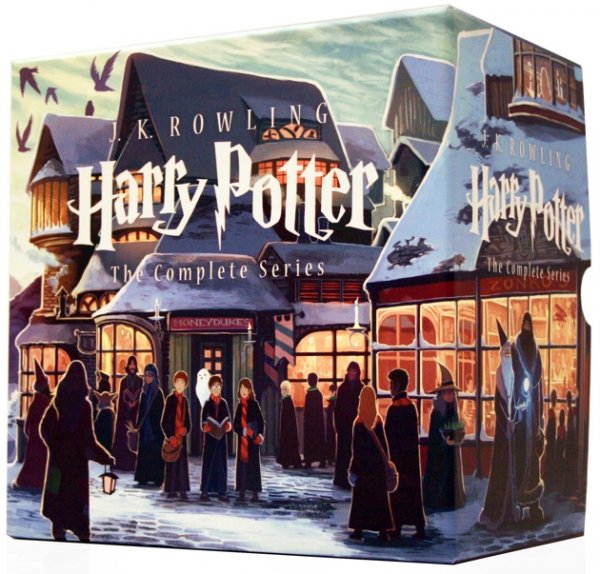
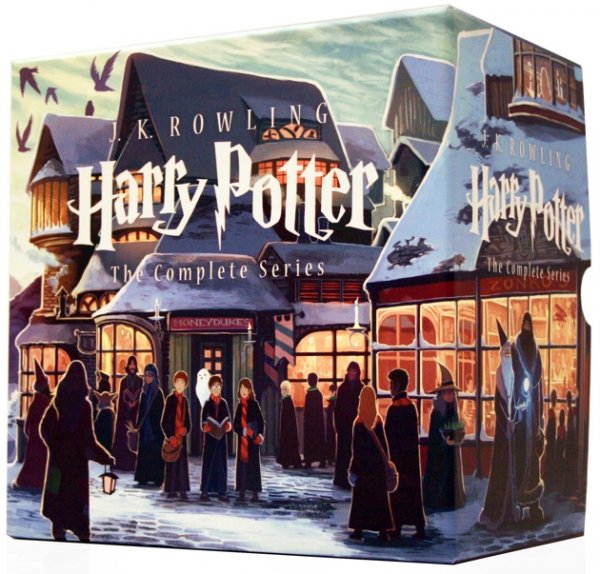
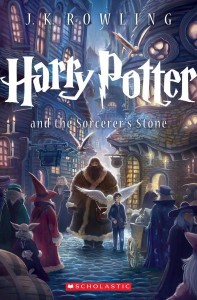

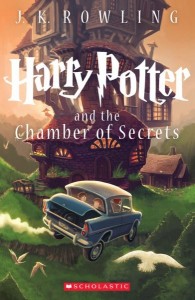
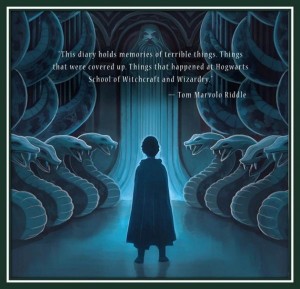
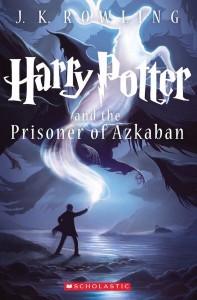

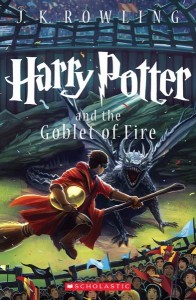

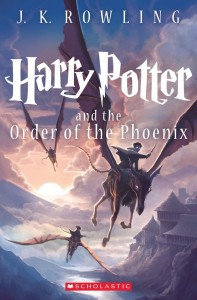
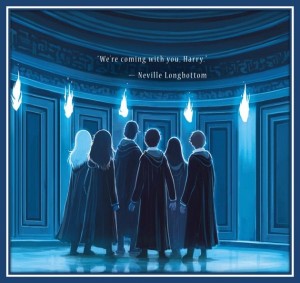

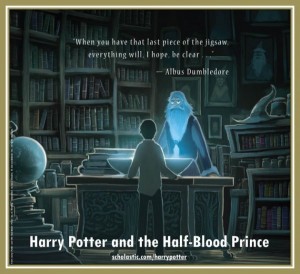
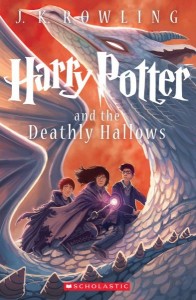
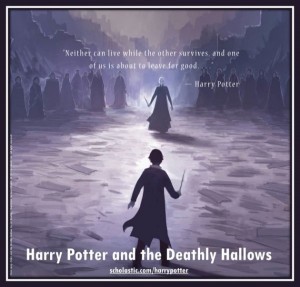


 Nel cast di Kick-Ass 2 spiccano anche attori del calibro di
Nel cast di Kick-Ass 2 spiccano anche attori del calibro di 


















 la giovane
la giovane 


