Un famoso detto, diffuso nella
Hollywood degli addetti ai lavori sin dai gloriosi anni ’30,
afferma che il cinema americano è stato fondato in realtà da donne,
ebrei e immigrati. Tralasciando la più che evidente connotazione
xenofoba e misogina di base, tale affermazione non può che trovare
un forte riscontro in tutte le sue tre dimensioni fondamentali, a
dimostrazione di come, in particolare nel mondo dell’arte, molto
spesso le dicerie e i luoghi comuni tendono ad affondare le proprie
radici in un qualche sostrato di verità. Se grandi autori, di
chiara origine europea del calibro di Otto Preminger, Frank
Capra, Billy Wyilder e Duglas Sirk
riuscirono a portare alla luce il mito tutto americano del
self-made director e a far brillare di gloria in tutto il
mondo la cinematografia a stelle e strisce, il ruolo femminile
all’interno dei vari settori della settima arte è stato a lungo
sottovalutato e tenuto all’oscuro delle cronache più o meno
ufficiali, riuscendo fortunatamente a tornare a far sentire la
prioria voce soltanto a cavallo degli anni ’70 e ’80 del Novecento,
grazie soprattutto alla sinergia fra gli studi di riscoperta delle
modalità produttive e fruitive del cinema delle origini da una
parte e la corrente delle teorie filmiche di matrice femminista
dall’altra.
Non è per nulla un segreto a
esempio il fatto che il corpo femminile fosse divenuto fin da
subito un soggetto cardine e appetibile nelle prime vedute animate
di fine XIX secolo, così come dimostrano le numerose “danze
serpentine” di chiara matrice erotica interpretate da celebri
proto-dive provenienti dai cabaret e dai teatri di vaudeville, come
per esempio Amy Muller e Annabelle
Whitford Moore, allo stesso modo di alcuni dei primi
proto-generi cinematografici denominati “film dal buco della
serratura” – o in maniera ben più esplicita “film dei guardoni” –,
tutti precedenti all’introduzione dei primi sistemi di censura e
tarati su un più che dichiarati intento voyeurista e licenzioso. In
realtà però, oltre che come soggetti prediletti, le donne assunsero
un ruolo integrante (seppur in sordina) all’interno delle attività
di elaborazione delle pellicole, venendo impiegate come manovalanza
attiva all’interno di alcune delle prime case produttrici – come ad
esempio la Star Film di George Méliés e la Edison
Company – per colorare manualmente i singoli fotogrammi attraverso
alcune tecniche primordiali quali il pochoir (il celebre processo
“a tampone”) e il più evoluto viraggio. Gli stessi fratelli
Lumiére, infatti, usarono parte delle operaie assunte nelle loro
fabbriche di prodotti fotografici per sviluppare, colorare e
confezionare i propri film.
In seguito all’evoluzione dello
studio system hollywoodiano, a partire dalla metà degli
anni ’10, furono appunto le donne a ricoprire compiti di sempre
maggiore responsabilità e competenza all’interno delle crews dei
grandi studios, tra cui spiccano la figura della segretaria di
edizione (non a caso ribattezzata in seguito “script
girl”), quella di costumista e soprattutto di montatore, uno
dei ruoli fondamentali del processo di post-produzione e che
divenne, soprattutto a cavallo degli anni ’40 e ’50, vero
appannaggio femminile e che avrebbe dato luogo a una lunga e
florida tradizione. Se il celebre sodalizio fra Martin Scorsese e Thelma
Schoonmaker può essere considerato come una delle formule
più celebri e vincenti in tal senso, allo stesso modo si spiega la
tendenza dello stesso Hitchcock a volere accanto a sé la moglie e
collaboratrice Alma Reville durante le sessioni in
moviola, poiché egli riteneva essenziale un attento occhio
femminile durante la fase più delicata dell’intera creazione
filmica.
La celebre teorica del cinema
tedesca Lotte Eisner, oltre a riconoscere
l’indubbio valore della figura della diva incarnato da celebri
interpreti come Pina Menichelli, Lyda
Borelli, Francesca Bertini, Asta Nielsen e Louise
Brooks – in quanto unico vero ruolo filmico in cui è
appunto la donna a dominare per intero la scena e a imporsi sul
maschio, inerme al suo fascino –, cercò di dimostrare come già nei
tardi anni ’40 si cercasse di rivendicare la centralità della
dimensione femminile in quello che appare come il ruolo cardine e
più delicato dell’intera produzione creativa e fattuale del film,
ovvero la regia. Se pensiamo ad alcune celeberrime e apprezzate
cineaste dell’epoca moderna e post-moderna quali Agnès
Varda, Marie Huillé, Liliana Cavani, Lina Wertmüller, Kathryn
Bigelow, Nora Ephron e Jane Campion non
possiamo non rimanere perplessi per come in decenni l’industria del
cinema, in tutte le sue correnti ed epoche, abbia tentato di
nascondere, e in un certo senso anche di ostacolare, la presenza –
per altro ancora oggi abbastanza esigua – della donna in quanto
figura in grado di incarnare un ruolo creativo e operativo rimasto
si dall’inizio appannaggio quasi esclusivo dell’universo
maschile.
I primi accenni di una qualche
figura di donna direttamente coinvolta nella fase di progettazione
e messa in scena in un prodotto di tipo filmico risalgono
addirittura all’epoca precedente l’invenzione del cinema stesso, e
vedono come protagonista la ricca ereditiera inglese Lizzie
Whitley, moglie dell’inventore francese Louise
Aimè Augustin Le Prince, colui che è rimasto a lungo
sconosciuto alle cronache ufficiali e che tutt’oggi è considerato
come il padre apocrifo della settima arte. Fu infatti proprio la
giovane pittrice che, trasferitasi a New York nel 1981 per lavorare
nell’istituto per non udenti di Washington Heights, collaborò
assieme al marito e all’assistente Joseph Banks
nella realizzazione di una primordiale cinepresa a 16 lenti in
grado di riprendere fino a 10-12 fotografie al secondo, tutt’oggi
considerata come il primo vero dispositivo proto-cinematografico
antecedente addirittura al kinetoscopio di Edison e al
Cinematograph dei Lumière. Seppur non vi siano ancora prove certe
di un suo diretto coinvolgimento nel progetto, è comunque indubbia
la presenza e il supporto operativo fornito dalla giovane Lizzie
durante la realizzazione del primo filmato della storia ad oggi
rinvenuto, una veduta animata di appena tre secondi realizzata da
Le Prince nel 1888 proprio nel giardino della famiglia Whitley a
Oakwood Grange Road nello Yorkshire, ben presto rinominata
Roudnhay Garden Scene. È comunque certo
che, dopo la misteriosa e ancora irrisolta sparizione del marito
avvenuta nel settembre del 1890 durante un viaggio in treno da
Digione a Parigi, fu proprio la determinazione della donna a
permettere la prosecuzione delle rivoluzionarie sperimentazioni
riguardati le immagini in movimento, tutto prima che gli acerrimi
concorrenti americani e francesi prendessero il sopravvento e
aprissero definitivamente le porte alla nascita della
cinematografia.
 La documentazione storica
ufficiale è solita in realtà considerare la francese Alice
Guy-Blaché come la prima donna ad aver ricoperto
ufficialmente il primo vero ruolo stabile da regista all’interno di
una delle prime grandi case di produzione europee, la Gaumont,
iniziando la sua carriera come semplice segretaria ed esordendo
dietro la macchina da presa già nel 1896 con il cortometraggio
La Fée aux chouz, realizzato con alcuni
spezzoni di pellicola ottenuti di nascosto da rivenditori non
autorizzati. Assunta stabilmente alla guida della neonata major
d’oltralpe, Alice-Guy ebbe modo di realizzare una decina di
pellicole fra mediometraggi e qualche lungometraggio nel periodo
compreso fra il 1906 e il 1920, tra cui vanno ricordati i drammi
The Face at the Window (1912) e
Beneath the Czar realizzati per conto
dell’americana Solax Film Company nonché una delle prime pellicole
religiose della storia, Naissance, vie et mort de Notre
Seigneur Jesus Christ (1906), distribuita in scene a
bobine indipendenti. Nel frattempo decise di dedicarsi anche alla
carriera di sceneggiatrice e produttrice assieme al marito Herbert,
prima di lasciare a Louis Feuillade il ruolo di
regista ufficiale della compagnia e ritirarsi a vita privata,
imprimendo un segno indelebile all’interno della memoria collettiva
del cinema mondiale.
La documentazione storica
ufficiale è solita in realtà considerare la francese Alice
Guy-Blaché come la prima donna ad aver ricoperto
ufficialmente il primo vero ruolo stabile da regista all’interno di
una delle prime grandi case di produzione europee, la Gaumont,
iniziando la sua carriera come semplice segretaria ed esordendo
dietro la macchina da presa già nel 1896 con il cortometraggio
La Fée aux chouz, realizzato con alcuni
spezzoni di pellicola ottenuti di nascosto da rivenditori non
autorizzati. Assunta stabilmente alla guida della neonata major
d’oltralpe, Alice-Guy ebbe modo di realizzare una decina di
pellicole fra mediometraggi e qualche lungometraggio nel periodo
compreso fra il 1906 e il 1920, tra cui vanno ricordati i drammi
The Face at the Window (1912) e
Beneath the Czar realizzati per conto
dell’americana Solax Film Company nonché una delle prime pellicole
religiose della storia, Naissance, vie et mort de Notre
Seigneur Jesus Christ (1906), distribuita in scene a
bobine indipendenti. Nel frattempo decise di dedicarsi anche alla
carriera di sceneggiatrice e produttrice assieme al marito Herbert,
prima di lasciare a Louis Feuillade il ruolo di
regista ufficiale della compagnia e ritirarsi a vita privata,
imprimendo un segno indelebile all’interno della memoria collettiva
del cinema mondiale.
Negli stessi anni in cui in Francia
Alice-Guy porta avanti la sua gloriosa fama di pioniera, in Italia
è invece la giovane insegnante e modista salernitana Elvira
Notari a rompere precocemente i rigidi tabù dell’epoca,
decidendo di trasferirsi a Napoli e di fondare nel 1902, assieme al
marito fotografo Nicola, la casa di produzione Film Dora – in
seguito meglio nota come Dora Film – iniziando a progettare e
filmare documentari e cortometraggi di fiction. Passata alla regia
di alcuni dei primi lungometraggi tratti da noti romanzi popolari e
di cronaca rosa, tra i quali spiccano Il processo
Cuocolo (1909), Bufera
d’anime (1911) e Errore
giudiziario (1913), la Notari si distingue subito
attraverso una modalità di realizzazione e gestione del tutto
innovativa che prevedeva non solo il pieno controllo di tutte le
varie fasi di ideazione e realizzazione dei propri progetti, ma
oltretutto l’impiego di rivoluzionari e precoci meccanismi di
colorazione e accoppiamento sonoro delle pellicole, oltre alla
caratterizzazione di personaggi per lo più scabrosi e
anticonvenzionali che le avrebbero causato grossi grattacapi col
futuro regime fascista. Estremamente carismatica, oculata esperta
di marketing e decisa a gestire personalmente i rapporti con gli
organi di stampa e promozione, la Notari realizzò oltre sessanta
film dal 1906 al 1929 – alcuni dei quali dei veri e propri successi
popolari come ’A legge e
’Nfamia (1924) – fondando inoltre la prima Scuola
d’Arte Cinematografica italiana in cui veniva insegnato uno stile
di recitazione fortemente naturalistico e agli antipodi rispetto
alle caricate performance divistiche ben note a quel tempo. In
seguito all’incapacità tecnica ed economica di rimanere al passo
con il dilagare delle prime pellicole sonore, la Dora Film chiuse i
battenti a inizio anni ’30, venendo convertita in società di
distribuzione e continuando a tenere alto il nome della sua donna
di successo, colei che ebbe il grande coraggio di dirigere racconti
estremamente crudi e profondamente scandalosi secondo gli standard
del pubblico del tempo.
Sempre nell’Italia a cavallo degli
anni ’10 e ’20 ecco fare la sua comparsa una nuova figura femminile
estremamente importante per la storia del cinema quale
Diana Karenne, nata in Polonia come
Leucadia Konstantin e trasferitasi nel nostro
paese nel 1914, divenendo ben presto una delle dive più amate e
pagate di tutto il cinema europeo. Estremamente libertina, amante
degli sport estremi come il volo e le corse automobilistiche,
pericolosamente affascinante e ben dotata artisticamente, la
Karenne debuttò sul grande schermo nel 1916 con
Passione tziagana di E.M.
Pasquali, fondando nel 1917 assieme al fratello David la
David-Karenne Film che produsse il suo esordio da regista
Pierrot lo stesso anno. Interprete di
celebri pellicole quali La contessa
Arsenia (1916), Redenzione
(1919) e La fiamma e la cenere (1919) in
cui riuscì a creare su di sé il personaggio conturbante di una
femme fatale vorace e distruttiva, fu anche apprezzata regista e
sceneggiatrice di progetti ambiziosi e di chiaro indirizzo
femminista come Justice de femme! (1917)
e Ave Maria (1920), prima di dedicarsi
definitivamente al ruolo di attrice a tempo pieno, anche fuori
dall’Italia, dopo l’inizio degli anni ’20. Fu l’unica delle grandi
dive italiane a non prendere mai marito, decidendo di rivendicare
sempre e comunque la propria libertà personale e creativa
all’interno di una società estremamente maschilista e piena di tabù
etici e morali. Dopo una florida carriera attoriale e una decina di
pellicole da lei liberamente direttamente scritte, dirette e
montate, la Karenne si congedò dal grande schermo nel 1939 con
Manon Lescaut di Carmine
Gallone, morendo tragicamente in seguito alle disastrose
ferite riportate durante un bombardamento avvenuto nel luglio del
1940 nella città di Aquisgrana.
Sposandoci in territorio tedesco,
il periodo che precede la nascita del cinema sonoro è dominato da
due figure di donne capaci di mettere tutta la propria creatività e
capacità tecnica al servizio della regia di opere estremamente
sperimentali e anticonvenzionali, dimostrando dunque non solo un
grande coraggio ma bensì una forte tendenza a infrangere regole
sociali e artistiche già all’epoca estremamente fossilizzate.
Erna Niemeyer, versatile e prolifica artista
capace di muoversi con estrema disinvoltura attraverso le più
disparate forme di espressione, divenne già all’inizio degli anni
’20 una delle più apprezzate animatrici europee, sviluppando una
rivoluzionaria serie di procedimenti con cui ritagliare e
fotografare direttamente su pellicola porzioni di materiali
eterogenei che divennero la base per celebri lavori di avanguardia,
tra cui vanno certamente ricordati la famosa Dyagonal
symphonie di Viking Eggeling e la
ben più celebre serie dei Rythmus
(1921-1923-1925) di Hans Richter. Allo stesso
modo anche la figura di Lotte Reiniger non può
passare del tutto inosservata nel panorama del cinema animato, se
si pensa ad alcune delle sue più splendide e sensazionali opere
grafiche, realizzate mediante l’impiego di elaborate e
raffinatissime silhouettes nere su mirabolanti sfondi colorati a
mano, tra cui spiccano il capolavoro Le avventure del
principe Achmed (1926) e una serie di pellicole
ispirate a famosi racconti per bambini come
Cenerentola e La bella
addormentata nel bosco, entrambi del 1922.
Dalla potenza tutta artigianale dei
racconti animati si passa poi alla poetica del documentario, reso
più che mai celebre nella neonata Unione Sovietica da
Esfir’ Šub, giovane e intraprendente cineasta che
fece tesoro delle innovazioni di montaggio messe a punto dai
colleghi della Scuola Statale di Cinema di Mosca per realizzare
stupefacenti reportage storici dal sapore sperimentale come
La fine della dinastia dei Romanov (1927)
e La grande strada (1927), entrambi
sviluppati mediante un collage di riprese amatoriali e
professionali di repertorio, allo stesso modo di La
Russia di Nicola II e Lev Tolstoj (1928), dando di
fatto i natali al genere tutto di nicchia del “documentario di
montaggio”.
In quegli stessi anni
Alexandra Khokhlova, fascinosa moglie del celebre
cineasta e teorico Lev Kuleshov, dopo aver dato il
via a una robusta carriera di attrice attraverso uno stile nervoso
e anti-naturalistico – ben rappresentato da alcune pellicole
dirette dal marito come Le avventure di Mr West nel
paese dei bolscevichi (1924) e Dura
lex (1926) – si dedicò anche alla scrittura e alla
co-regia di due film alquanto discussi a causa dei loro apparenti
contenuti eccessivamente “spinti”, Discendere da un
vulcano (1941) e Noi veniamo dagli
Urali (1943).
Se in quegli stessi decenni negli
Stati Uniti la fotografa Margaret Burke-White
tentava anch’essa la strada del cinema documentario di denuncia
sociale all’interno del collettivo di sinistra Workers’ Film and
Photo League, in Francia ecco emergere la figura eclettica e
controversa di Germaine Dulac, prima e unica
autrice ad aver non solo avuto accesso diretto a tutte le più
importanti forme d’arte (pittura, scultura, fotografia, musica,
danza e cinema), ma oltretutto a essere riuscita a imporsi come
vero e proprio simbolo della creatività sperimentale europea a
cavallo degli anni ’20 e ’30, attraversando trasversalmente – e con
grandi risultati – le principali avanguardie cinematografiche del
tempo, partendo dalle vocazioni poetiche dell’impressionismo con
La souriante madame Beudet (1923),
passando attraverso i primordi visionari surrealisti de
La coquille et le clergyman (1928) fino a
toccare le punte totalmente astratte e anti-figurative del cinéma
pur con gli esperimenti plastici di Disque
927 (1928) e Arabesque
(1929). Mentre le performance estreme e anticonvenzionali della
Dulac non mancavano di dividere aspramente il pubblico e la
critica, molto più lineare – ma altrettanto coraggiosa – risulta la
produzione di Marie Epstein, sorella del ben più
celebre teorico e cineasta visionario (e padre del concetto di
photogenie) Jean, la quale fin dal 1928 iniziò a collaborare
assiduamente col collega Jean Benoît-Lévy nella
realizzazione di drammi estremamente struggenti, polarizzati verso
una forte denunce nei confronti del degrado e della povertà
sociale, anticipando di fatto la futura corrente del realismo
poetico di metà anni ’30. Fra le opere più rappresentative in tal
senso vanno ricordate certamente Âmes
d’enfants (1928) e
Maternité (1929), oltre che il
celeberrimo La Maternelle, una delle
prime opere filmiche a trattare direttamente il tema dell’abbandono
e delle turbe infantili ancor prima di I bambini ci
guardano (1943) di De Sica e
Sciuscià (1946) di Rossellini.
 I decenni interessati
dall’avvento della dittatura nazionalsocialista e dallo scoppio
della Seconda Guerra Mondiale costituiscono per la Germania il
periodo di maggior produttività di Leni von
Riefenstahl, una delle autrici più controverse e celebri
di tutta la storia del cinema internazionale durante l’oscuro
periodo delle macchinazioni pre e post bellica, gli stessi decenni
in cui la sceneggiatrice Thea von Harbou
instaurava col compagno Fritz Lang un forte e
proficuo sodalizio sentimentale e professionale. Aspirante ballerina di cabaret costretta a ritirarsi dalla
professione a causa di un precoce infortunio, si interessò molto
presto alla recitazione durante l’età d’oro del cinema muto,
esordendo nel 1926 con il lungometraggio La montagna
dell’amore diretto da Arnold Fanck,
autore con cui intraprenderà un duraturo legame all’interno di
pellicole appartenenti al genere nazionale – all’epoca molto in
voga – dei così detti “film della montagna”, tra cui Il
grande salto (1927), Tempesta sul Monte
Bianco (1930) e Ebrezza
bianca (1930). Dopo essere stata in contesa assieme a
Marlene Dietrich per il ruolo da protagonista nel
celebre L’angelo azzurro (1930) di
Josef von Sternberg e aver collaborato con
G.W. Pabst in La tragedia di Pizzo
Palù (1929), nei primi anni ’30 la Riefenstahl affina
grazie a Fanck le sue doti di montatrice e sceneggiatrice,
esordendo alla regia nel 1932 con La bella
maledetta – da lei anche scritto e interpretato –
prima che l’avvento del nazismo le facesse maturare una vera e
propria ossessione per Hitler, al quale scrisse in privato per
ottenere udienza. Fu proprio il fuhrer che, dopo aver ammirato le
straordinarie doti atletiche e tecniche della giovane autrice nel
film in doppia lingua S.O.S. Iceberg
(1933), decise di affidarle la realizzazione di un cortometraggio
con cui immortalare la prima sessione del congresso del Partito
Nazista del 1933. Purtroppo, in seguito all’epurazione dello
squadrone delle SA durante la celebre Notte dei Lunghi
Coltelli, La vittoria della
fede venne sequestrato e distrutto, poiché conteneva
inquadrare di alcuni dei maggiori capi dell’ex divisione personale
del dittatore, comprese le immagini del generale Ernst
Röhm. L’anno successivo venne data l’opportunità alla
Riefenstahl di girare una nuova pellicola – questa volta un
lungometraggio dichiaratamente propagandistico – relativo al
secondo incontro ufficiale del partito avvenuto a Norimberga,
intitolato Il trionfo della volontà.
Grazie alle sperimentazioni tecniche messe in atto attraverso
questo ambizioso progetto e ormai capacissima di dirigere
addirittura dieci équipe di operatori contemporaneamente, dopo la
breve parentesi del cortometraggio I giorni della
libertà – Il nostro esercito (1935) dedicato alle
forze armate naziste, nel 1938 la Riefenstahl si imbarcò nel
titanico progetto in due parti di
Olympia, film dedicato alla
documentazione degli storici Giochi Olimpici di Berlino e primo
grande esempio di una narrazione sportiva realizzata mediante
soluzioni visive (ralenti, teleobbiettivi, montaggio in
multicamera, carrellate aeree e a bordopista, ecc.) che avrebbero
costituito la base per tutte le future immagini atletiche
cine-televisive. Il suo stile monumentale e velatamente polarizzato
sull’ideologia politica dominante le causarono però numerosi
grattacapi durante la fine della guerra, quando, dopo essersi
rifugiata in uno sperduto paesino delle alpi svizzere, venne
rintracciata e ricondotta in Germania, dove fu l’unica regista –
assieme al collega Veit Harlan – ad essere pubblicamente accusata e
perseguita con l’accusa di sostegno e favoreggiamento del decaduto
regime nazista. Dopo essere rimasta a lungo lontano dai set a causa
della sua cattiva fama, la Riefenstahl riuscì timidamente a
riaffacciarsi alla professione solo nel 1954 con la regia e
l’interpretazione di Tieflad (1954)
diradando sempre più le proprie apparizioni pubbliche e
professionali ne corso degli anni, concludendo la propria carriera
nel 1993 con la celebre rievocazione storica delle proprie imprese
nel documentario La forza delle immagini
di Ray Müller e l’avvio di un ultimo progetto
registico dal titolo Un sogno d’Africa,
distribuito postumo nel 2003.
I decenni interessati
dall’avvento della dittatura nazionalsocialista e dallo scoppio
della Seconda Guerra Mondiale costituiscono per la Germania il
periodo di maggior produttività di Leni von
Riefenstahl, una delle autrici più controverse e celebri
di tutta la storia del cinema internazionale durante l’oscuro
periodo delle macchinazioni pre e post bellica, gli stessi decenni
in cui la sceneggiatrice Thea von Harbou
instaurava col compagno Fritz Lang un forte e
proficuo sodalizio sentimentale e professionale. Aspirante ballerina di cabaret costretta a ritirarsi dalla
professione a causa di un precoce infortunio, si interessò molto
presto alla recitazione durante l’età d’oro del cinema muto,
esordendo nel 1926 con il lungometraggio La montagna
dell’amore diretto da Arnold Fanck,
autore con cui intraprenderà un duraturo legame all’interno di
pellicole appartenenti al genere nazionale – all’epoca molto in
voga – dei così detti “film della montagna”, tra cui Il
grande salto (1927), Tempesta sul Monte
Bianco (1930) e Ebrezza
bianca (1930). Dopo essere stata in contesa assieme a
Marlene Dietrich per il ruolo da protagonista nel
celebre L’angelo azzurro (1930) di
Josef von Sternberg e aver collaborato con
G.W. Pabst in La tragedia di Pizzo
Palù (1929), nei primi anni ’30 la Riefenstahl affina
grazie a Fanck le sue doti di montatrice e sceneggiatrice,
esordendo alla regia nel 1932 con La bella
maledetta – da lei anche scritto e interpretato –
prima che l’avvento del nazismo le facesse maturare una vera e
propria ossessione per Hitler, al quale scrisse in privato per
ottenere udienza. Fu proprio il fuhrer che, dopo aver ammirato le
straordinarie doti atletiche e tecniche della giovane autrice nel
film in doppia lingua S.O.S. Iceberg
(1933), decise di affidarle la realizzazione di un cortometraggio
con cui immortalare la prima sessione del congresso del Partito
Nazista del 1933. Purtroppo, in seguito all’epurazione dello
squadrone delle SA durante la celebre Notte dei Lunghi
Coltelli, La vittoria della
fede venne sequestrato e distrutto, poiché conteneva
inquadrare di alcuni dei maggiori capi dell’ex divisione personale
del dittatore, comprese le immagini del generale Ernst
Röhm. L’anno successivo venne data l’opportunità alla
Riefenstahl di girare una nuova pellicola – questa volta un
lungometraggio dichiaratamente propagandistico – relativo al
secondo incontro ufficiale del partito avvenuto a Norimberga,
intitolato Il trionfo della volontà.
Grazie alle sperimentazioni tecniche messe in atto attraverso
questo ambizioso progetto e ormai capacissima di dirigere
addirittura dieci équipe di operatori contemporaneamente, dopo la
breve parentesi del cortometraggio I giorni della
libertà – Il nostro esercito (1935) dedicato alle
forze armate naziste, nel 1938 la Riefenstahl si imbarcò nel
titanico progetto in due parti di
Olympia, film dedicato alla
documentazione degli storici Giochi Olimpici di Berlino e primo
grande esempio di una narrazione sportiva realizzata mediante
soluzioni visive (ralenti, teleobbiettivi, montaggio in
multicamera, carrellate aeree e a bordopista, ecc.) che avrebbero
costituito la base per tutte le future immagini atletiche
cine-televisive. Il suo stile monumentale e velatamente polarizzato
sull’ideologia politica dominante le causarono però numerosi
grattacapi durante la fine della guerra, quando, dopo essersi
rifugiata in uno sperduto paesino delle alpi svizzere, venne
rintracciata e ricondotta in Germania, dove fu l’unica regista –
assieme al collega Veit Harlan – ad essere pubblicamente accusata e
perseguita con l’accusa di sostegno e favoreggiamento del decaduto
regime nazista. Dopo essere rimasta a lungo lontano dai set a causa
della sua cattiva fama, la Riefenstahl riuscì timidamente a
riaffacciarsi alla professione solo nel 1954 con la regia e
l’interpretazione di Tieflad (1954)
diradando sempre più le proprie apparizioni pubbliche e
professionali ne corso degli anni, concludendo la propria carriera
nel 1993 con la celebre rievocazione storica delle proprie imprese
nel documentario La forza delle immagini
di Ray Müller e l’avvio di un ultimo progetto
registico dal titolo Un sogno d’Africa,
distribuito postumo nel 2003.
A conclusione di questo parziale
excursus dedicato alla gloriosa e semi-sconosciuta storia
della regia al femminile, spostando di qualche decade il punto
focale della nostra analisi, vale la pena di valorizzare l’operato
di una delle poche vere autrici dell’est Europa, la praghese
Věra Chytilová, cineasta visionaria ed eclettica
passata alla storia per i suoi esordi nei primi anni ’60 – in piena
influenza delle nouvelle vague continentali – attraverso pellicole
d’avanguardia e ricche di uno stile comico-surreale, tra cui vanno
ricordate certamente Qualcosa d’altro
(1963), Tavola calda universo (1965) e il
grottesco Le margheritine (1966), prima
che i fatti della Primavera di Praga gettassero nell’oscurità molti
dei suoi lavori, rendendoli reperibili solo nei tardi anni ’80,
come accade per Il gioco della mela,
realizzato in realtà nel 1976.
 Il colore rosa, fatte le
dovute eccezioni kitsch del cinema di Almodovar,
non è molto presente nelle palette delle immagini filmiche, ma lo
spirito tutto femminile che questo cromatismo ha saputo (e sa
tutt’ora) consegnare al nobile ruolo della regia cinematografica
appare indubbiamente uno degli aspetti più belli e sinceri che le
pellicole – o i sensori dell’era digitatale – si rendono capaci di
restituire ad ogni singolo spettatore, sia esso uomo o donna.
Il colore rosa, fatte le
dovute eccezioni kitsch del cinema di Almodovar,
non è molto presente nelle palette delle immagini filmiche, ma lo
spirito tutto femminile che questo cromatismo ha saputo (e sa
tutt’ora) consegnare al nobile ruolo della regia cinematografica
appare indubbiamente uno degli aspetti più belli e sinceri che le
pellicole – o i sensori dell’era digitatale – si rendono capaci di
restituire ad ogni singolo spettatore, sia esso uomo o donna.
 Independence Day
2, diretto ancora una volta da Roland
Emmerich, uscirà il 24 giugno 2016 dopo
vent’anni dal primo film. La sceneggiatura porterà la firma di
Carter Blanchard. Roland Emmerich
produrrà la pellicola insieme a Dean Devlin e
Harald Kloser.
Independence Day
2, diretto ancora una volta da Roland
Emmerich, uscirà il 24 giugno 2016 dopo
vent’anni dal primo film. La sceneggiatura porterà la firma di
Carter Blanchard. Roland Emmerich
produrrà la pellicola insieme a Dean Devlin e
Harald Kloser.
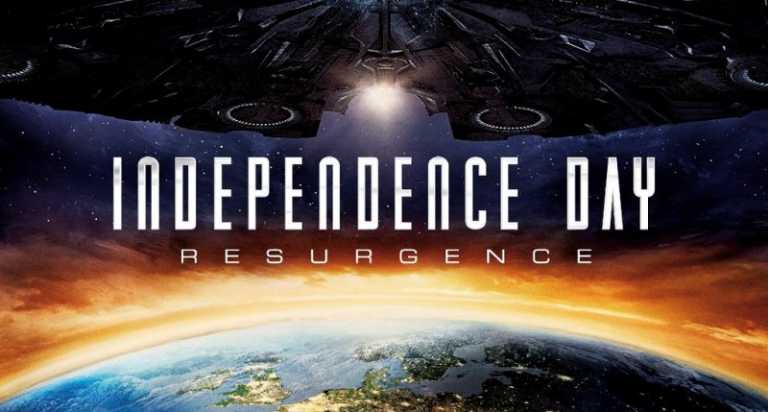

 erman in guerra, sorge
qualcosa di nuovo che mette l’umanitá in un pericolo mai conosciuto
prima”.
erman in guerra, sorge
qualcosa di nuovo che mette l’umanitá in un pericolo mai conosciuto
prima”.




 Animali fantastici dove
trovarli uscirà il 18 novembre 2016, e avrà come
protagonista Newt Scamandro, autore
de Gli animali fantastici dove trovarli, che avrà
esattamente 23 anni. Il film sarà ambientato a New York, 70 anni
prima delle vicende di Harry Potter. Nel cast Eddie
Redmayne,
Animali fantastici dove
trovarli uscirà il 18 novembre 2016, e avrà come
protagonista Newt Scamandro, autore
de Gli animali fantastici dove trovarli, che avrà
esattamente 23 anni. Il film sarà ambientato a New York, 70 anni
prima delle vicende di Harry Potter. Nel cast Eddie
Redmayne, 
 La sua interprete, la brava
La sua interprete, la brava
 In attesa di nuovi dettagli
in merito ricordiamo che
In attesa di nuovi dettagli
in merito ricordiamo che 



 La documentazione storica
ufficiale è solita in realtà considerare la francese Alice
Guy-Blaché come la prima donna ad aver ricoperto
ufficialmente il primo vero ruolo stabile da regista all’interno di
una delle prime grandi case di produzione europee, la Gaumont,
iniziando la sua carriera come semplice segretaria ed esordendo
dietro la macchina da presa già nel 1896 con il cortometraggio
La Fée aux chouz, realizzato con alcuni
spezzoni di pellicola ottenuti di nascosto da rivenditori non
autorizzati. Assunta stabilmente alla guida della neonata major
d’oltralpe, Alice-Guy ebbe modo di realizzare una decina di
pellicole fra mediometraggi e qualche lungometraggio nel periodo
compreso fra il 1906 e il 1920, tra cui vanno ricordati i drammi
The Face at the Window (1912) e
Beneath the Czar realizzati per conto
dell’americana Solax Film Company nonché una delle prime pellicole
religiose della storia, Naissance, vie et mort de Notre
Seigneur Jesus Christ (1906), distribuita in scene a
bobine indipendenti. Nel frattempo decise di dedicarsi anche alla
carriera di sceneggiatrice e produttrice assieme al marito Herbert,
prima di lasciare a Louis Feuillade il ruolo di
regista ufficiale della compagnia e ritirarsi a vita privata,
imprimendo un segno indelebile all’interno della memoria collettiva
del cinema mondiale.
La documentazione storica
ufficiale è solita in realtà considerare la francese Alice
Guy-Blaché come la prima donna ad aver ricoperto
ufficialmente il primo vero ruolo stabile da regista all’interno di
una delle prime grandi case di produzione europee, la Gaumont,
iniziando la sua carriera come semplice segretaria ed esordendo
dietro la macchina da presa già nel 1896 con il cortometraggio
La Fée aux chouz, realizzato con alcuni
spezzoni di pellicola ottenuti di nascosto da rivenditori non
autorizzati. Assunta stabilmente alla guida della neonata major
d’oltralpe, Alice-Guy ebbe modo di realizzare una decina di
pellicole fra mediometraggi e qualche lungometraggio nel periodo
compreso fra il 1906 e il 1920, tra cui vanno ricordati i drammi
The Face at the Window (1912) e
Beneath the Czar realizzati per conto
dell’americana Solax Film Company nonché una delle prime pellicole
religiose della storia, Naissance, vie et mort de Notre
Seigneur Jesus Christ (1906), distribuita in scene a
bobine indipendenti. Nel frattempo decise di dedicarsi anche alla
carriera di sceneggiatrice e produttrice assieme al marito Herbert,
prima di lasciare a Louis Feuillade il ruolo di
regista ufficiale della compagnia e ritirarsi a vita privata,
imprimendo un segno indelebile all’interno della memoria collettiva
del cinema mondiale. I decenni interessati
dall’avvento della dittatura nazionalsocialista e dallo scoppio
della Seconda Guerra Mondiale costituiscono per la Germania il
periodo di maggior produttività di Leni von
Riefenstahl, una delle autrici più controverse e celebri
di tutta la storia del cinema internazionale durante l’oscuro
periodo delle macchinazioni pre e post bellica, gli stessi decenni
in cui la sceneggiatrice Thea von Harbou
instaurava col compagno Fritz Lang un forte e
proficuo sodalizio sentimentale e professionale. Aspirante
I decenni interessati
dall’avvento della dittatura nazionalsocialista e dallo scoppio
della Seconda Guerra Mondiale costituiscono per la Germania il
periodo di maggior produttività di Leni von
Riefenstahl, una delle autrici più controverse e celebri
di tutta la storia del cinema internazionale durante l’oscuro
periodo delle macchinazioni pre e post bellica, gli stessi decenni
in cui la sceneggiatrice Thea von Harbou
instaurava col compagno Fritz Lang un forte e
proficuo sodalizio sentimentale e professionale. Aspirante  Il colore rosa, fatte le
dovute eccezioni kitsch del cinema di Almodovar,
non è molto presente nelle palette delle immagini filmiche, ma lo
spirito tutto femminile che questo cromatismo ha saputo (e sa
tutt’ora) consegnare al nobile ruolo della regia cinematografica
appare indubbiamente uno degli aspetti più belli e sinceri che le
pellicole – o i sensori dell’era digitatale – si rendono capaci di
restituire ad ogni singolo spettatore, sia esso uomo o donna.
Il colore rosa, fatte le
dovute eccezioni kitsch del cinema di Almodovar,
non è molto presente nelle palette delle immagini filmiche, ma lo
spirito tutto femminile che questo cromatismo ha saputo (e sa
tutt’ora) consegnare al nobile ruolo della regia cinematografica
appare indubbiamente uno degli aspetti più belli e sinceri che le
pellicole – o i sensori dell’era digitatale – si rendono capaci di
restituire ad ogni singolo spettatore, sia esso uomo o donna.
 “È tutto un universo
collegato”, ha aggiunto Nichols. “Ed è così che dovrebbe
essere. Io per primo ne sono un sostenitore. Sono un grandissimo
fan dei fumetti e so che deve essere così. Ma le basi lanciate da
Zack Snyder in
“È tutto un universo
collegato”, ha aggiunto Nichols. “Ed è così che dovrebbe
essere. Io per primo ne sono un sostenitore. Sono un grandissimo
fan dei fumetti e so che deve essere così. Ma le basi lanciate da
Zack Snyder in 



 Di seguito la tracklist
della colonna sonora del film:
Di seguito la tracklist
della colonna sonora del film:



 Ma appena il successo bussa
alla loro porta devono fare i conti con il sottile tessuto che
tiene insieme il loro amore. Nel cast anche il premio Oscar
J.K. Simmons.
Ma appena il successo bussa
alla loro porta devono fare i conti con il sottile tessuto che
tiene insieme il loro amore. Nel cast anche il premio Oscar
J.K. Simmons.
 “Non mandano mai tutta la
sceneggiatura, quando mi chiesero di essere presente in AoU mi
spedirono due scene. C’erano circa due ore e sette minuti di film
intorno a quelle due scene, ma io non le ho mai lette. Alla
premiere ho pensato che fosse davvero figo. Ero con mio figlio e
pensavo che sarebbe stato davvero bello perché mi avrebbe visto in
quelle due scene del film con i Vendicatori. Ma alla fine del film,
quando si vede la scena in cui Cap sta per dire “Vendicatori
Uniti!” io ho pensato “porca miseria sono un Vendicatore!” e così
tutti a dirmi “amico sei un f*****o Avenger, è magnifico”… Quindi,
questa è al storia della mia vita alla
“Non mandano mai tutta la
sceneggiatura, quando mi chiesero di essere presente in AoU mi
spedirono due scene. C’erano circa due ore e sette minuti di film
intorno a quelle due scene, ma io non le ho mai lette. Alla
premiere ho pensato che fosse davvero figo. Ero con mio figlio e
pensavo che sarebbe stato davvero bello perché mi avrebbe visto in
quelle due scene del film con i Vendicatori. Ma alla fine del film,
quando si vede la scena in cui Cap sta per dire “Vendicatori
Uniti!” io ho pensato “porca miseria sono un Vendicatore!” e così
tutti a dirmi “amico sei un f*****o Avenger, è magnifico”… Quindi,
questa è al storia della mia vita alla  Possiamo quindi immaginare che il ruolo della Wallis
sarà chiave nel procedimento che vedrà risuscitare la Mummia del
titolo, che sarà interpretata da Sofia Boutella
(
Possiamo quindi immaginare che il ruolo della Wallis
sarà chiave nel procedimento che vedrà risuscitare la Mummia del
titolo, che sarà interpretata da Sofia Boutella
(


 Justice League Parte
I sarà diretto ancora una volta da Zack
Snyder ed è previsto per il 10 novembre 2017. Nel film
vedremo protagonista
Justice League Parte
I sarà diretto ancora una volta da Zack
Snyder ed è previsto per il 10 novembre 2017. Nel film
vedremo protagonista 

 Secondo quanto
riporta
Secondo quanto
riporta 

 Accompagnati
dall’interprete Helen Scott, i due staranno insieme una settimana
intera, durante la quale il grande autore britannico condividerà
con il suo giovane ammiratore i segreti del suo cinema. Da
quell’incontro nascono un’amicizia che dura per 20 anni e il volume
“Hitchcock/Truffaut” (in italiano Il cinema secondo
Hitchcock, edito dal Saggiatore) che il regista
francese amava chiamare “Hitchbook”. La Bibbia del
Cinema, il celebrato libro di Truffaut basato sulla sua
intervista al maestro, divenne il libro da leggere per gli
addetti ai lavori di tutto il mondo e ancora oggi ha lo stesso
valore di allora. Le conversazioni tra i due, infatti,
cambiarono profondamente la critica nei confronti dell’opera di
Hitchcock e destarono scandalo perché lo stesso
concetto di “cinema” venne totalmente sconvolto.
Accompagnati
dall’interprete Helen Scott, i due staranno insieme una settimana
intera, durante la quale il grande autore britannico condividerà
con il suo giovane ammiratore i segreti del suo cinema. Da
quell’incontro nascono un’amicizia che dura per 20 anni e il volume
“Hitchcock/Truffaut” (in italiano Il cinema secondo
Hitchcock, edito dal Saggiatore) che il regista
francese amava chiamare “Hitchbook”. La Bibbia del
Cinema, il celebrato libro di Truffaut basato sulla sua
intervista al maestro, divenne il libro da leggere per gli
addetti ai lavori di tutto il mondo e ancora oggi ha lo stesso
valore di allora. Le conversazioni tra i due, infatti,
cambiarono profondamente la critica nei confronti dell’opera di
Hitchcock e destarono scandalo perché lo stesso
concetto di “cinema” venne totalmente sconvolto.