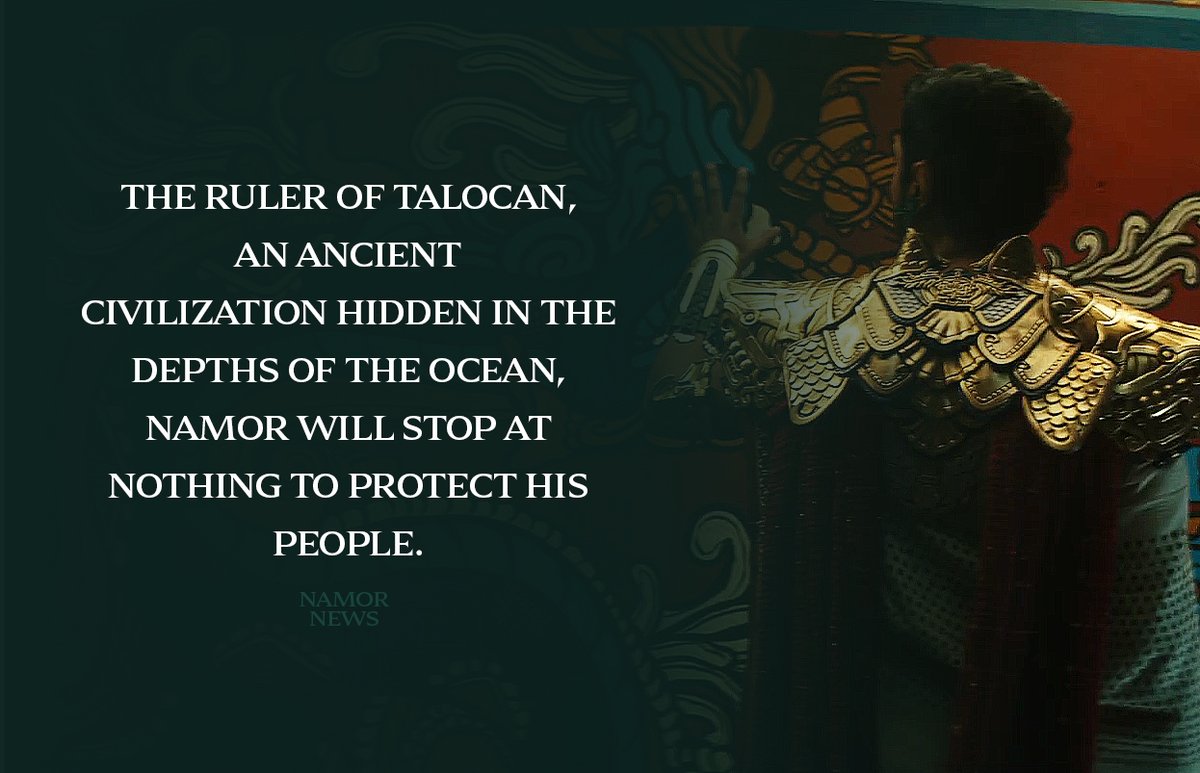E’ disponibile nelle sale italiane
Black Parthenope, film che segna l’esordio alla
regia di Alessandro Giglioli ed ambientato
interamente nella Napoli Sotterranea.
L’abisso partenopeo
Nella caotica città di Napoli, c’è
un luogo silenzioso vecchio di 3000 anni: la vasta città
sotterranea. Cécile, giovane imprenditrice
francese, è in città per la costruzione di parcheggi nel
sottosuolo. Scesa nelle viscere della città con
Yanis e Greta, suoi
collaboratori, il tecnico Gianni ed
Antonio, proprietario delle cave, incontrerà
Gennaro, storica guida del posto, contrario al
progetto. Imprigionata con gli altri sottoterra, tra morti violente
e antiche vestigia, Cécile, dovrà trovare
un’uscita. Una figura incappucciata la segue. Un essere reale o lo
spirito del luogo?
Da una location fortemente ispirata
come la labirintica Napoli sotterranea, si va definendo una storia
priva di una trama organica, che spinge verso i confini di genere
senza mai riuscire ad appropriarsene veramente. Black
Parthenope vuole abitare lo spazio narrativo di opere
abissali, il cui punto di non ritorno corrisponde solitamente
alle pieghe più contorte e celate dell’animo umano, concretizzate
da protagonisti che devono confrontarsi con l’estensione
caratteriale dei cunicoli che li circondano.

Alla ricerca dell’horror
Si dovrebbe dunque partire da una
caratterizzazione ottimale del gruppo di protagonisti, atta ad
identificare le diverse motivazioni e ideologie in contrasto, tra
chi vorrebbe modernizzare il senso di una città e fare i propri
interessi, e chi ritiene che così facendo si andrebbe a profanare
non solo un luogo, ma l’onore di un intero nucleo di cittadini.
Purtroppo, Black
Parthenope non rispecchia energia sufficiente tra registi
e attori per poter confezionare un horror italiano, come
vorrebbe presentarsi il progetto. La componente di genere scivola
tra le nostre dita a suon di jump scares premeditati,
figli della tradizione horror che ottiene buoni risultati in sala
ma non altrettanto dal punto di vista qualitativo. L’italianità del
progetto è invece incontrovertibilmente messa a repentaglio da
soluzioni di doppiaggio e gestione linguistica non ottimali, che
non riescono a conferire verosimiglianza a un gruppo di personaggi
già di per se mal assortito, impossibilitato nel relazionarsi l’uno
con l’altro e neanche
contro l’altro, per conferire dinamicità
alla storia.
Riprendendo gli stilemi del genere,
da The Descent (2005) al più recente
Necropolis – La città dei morti (2014),
Black Pathenope vuole riscoprire la grande
memoria popolare di una specifica area geografica, la città
sotterranea, che ancora incanta milioni di visitatori, grazie alle
leggende che sono sorte in quel contesto e vivono dell’immaginario
popolare, prima fra tutte la mitica storia del
Monaciello. L’antico “pozzaro”, che porta con sé
il proprio passato e lo patisce irrimediabilmente, è descritto come
“genius loci” del sottosuolo di Napoli,
la cui natura, sia essa buona o maligna, inquieta e perseguita i
protagonisti del film.

Due “Monacielli” a confronto
L’idea di una minaccia in bilico tra
il fisico e il trascendentale avrebbe funzionato perfettamente
nello scardinare le convinzioni dei protagonisti di Black
Parthenope e, in ultima istanza, fornire loro una nuova
consapevolezza. Al contrario, l’unico viaggio coerente sembra
essere quello di Cécile, che passa da un carattere
dispotico e anaffettivo a un nuovo punto di vista sulle proprie
emozioni e sul suo rapporto con l’autorità. Tuttavia, le
motivazioni, il modo di agire e lo stesso background di
Cécile, terribilmente ostacolato dalla figura
paterna, mai mostrata nel corso del film ma che sentenzia e
impartisce ordini da dietro la cornetta, rispecchia quasi in toto
quello della protagonista di
Necropolis, Scarlett
Marlowe.
In conclusione, Black
Parthenope fatica a trovare la propria identità non solo
all’interno del cinema di genere ma anche dell’attuale industria
produttiva italiana. Dopo che Paolo Sorrentino è
riuscito a raccontarci Napoli con una delicata ed incisiva
emotività, filtrata dagli occhi del giovane Fabietto
Schisa (Filippo Scotti) in
E’ stata la mano di Dio, è impossibile non
pensare, e di conseguenza elevare, il Monaciello
che guida l’immaginazione di Zia Patrizia
(Luisa
Ranieri), e che continuerà a vivere nel nostro
immaginario, rispetto a un Monaciello utilizzato
come puro figurante, in una caccia al thriller che cancella ogni
tentativo di sperimentazione narrativa.




 In Black Sails 2×02
Flint da a Dufresne qualche consiglio, mentre
Silver deve rendersi indispensabile. Intanto a Eleanor viene
chiesto di deporre un capitano e Rackham diventa
ambizioso.
In Black Sails 2×02
Flint da a Dufresne qualche consiglio, mentre
Silver deve rendersi indispensabile. Intanto a Eleanor viene
chiesto di deporre un capitano e Rackham diventa
ambizioso. In Black Sails 2×01
Flint e Silver affrontano il giudizio da parte
dell’equipaggio. Intanto Vane apprezza la sua nuova
posizione sull’isola.
In Black Sails 2×01
Flint e Silver affrontano il giudizio da parte
dell’equipaggio. Intanto Vane apprezza la sua nuova
posizione sull’isola.
 Black Sails è una
serie televisiva statunitense creata da Jon Steinberg e Robert
Levine per il canale via cavo Starz, trasmessa a partire dal 25
gennaio 2014. In Italia viene trasmessa dal 22 settembre 2014 su
AXN. La serie funge da prequel del romanzo di Robert Louis
Stevenson L’isola del tesoro.
Black Sails è una
serie televisiva statunitense creata da Jon Steinberg e Robert
Levine per il canale via cavo Starz, trasmessa a partire dal 25
gennaio 2014. In Italia viene trasmessa dal 22 settembre 2014 su
AXN. La serie funge da prequel del romanzo di Robert Louis
Stevenson L’isola del tesoro. La Starz ha annunciato
che Black Sails avrà una terza stagione.
L’ufficializzazione di un terzo ciclo di episodi per la serie tv
creata da Jonathan Steinberg è avvenuta nel corso
del New York Comic Con 2014, durante il quale è stato anche
presentato il primo trailer di Black Sails
2.
La Starz ha annunciato
che Black Sails avrà una terza stagione.
L’ufficializzazione di un terzo ciclo di episodi per la serie tv
creata da Jonathan Steinberg è avvenuta nel corso
del New York Comic Con 2014, durante il quale è stato anche
presentato il primo trailer di Black Sails
2.

 Di base, il film ha una
trama sostanziosa. Tratto dal racconto The Black Phone di
Joe Hill (il figlio del celebre scrittore
Di base, il film ha una
trama sostanziosa. Tratto dal racconto The Black Phone di
Joe Hill (il figlio del celebre scrittore  Oltre al grande nome dietro
al carnefice al centro del film, i due giovani interpreti non sono
da meno. Mason Thames (Finney)
riesce bene nella parte del ragazzino timido e insicuro, sensibile
e per questo bullizzato. Vedere la trasformazione del personaggio
in una situazione ai limiti della sopravvivenza è davvero
avvincente. Non è da meno Madeleine McGraw, la
giovane attrice che interpreta Gwen Shaw: il suo
personaggio è forse quello più stratificato, alle prese con un
padre violento, dei sogni ingombranti e un fratello scomparso. Su
di lei gravano tutte le pressioni degli adulti attorno. L’emotività
della ragazzina viene resa perfettamente dall’attrice, in grado di
passare dal riso al pianto senza mai sembrare forzata. In generale,
gli interpreti più giovani sono la nota di vanto del film.
Oltre al grande nome dietro
al carnefice al centro del film, i due giovani interpreti non sono
da meno. Mason Thames (Finney)
riesce bene nella parte del ragazzino timido e insicuro, sensibile
e per questo bullizzato. Vedere la trasformazione del personaggio
in una situazione ai limiti della sopravvivenza è davvero
avvincente. Non è da meno Madeleine McGraw, la
giovane attrice che interpreta Gwen Shaw: il suo
personaggio è forse quello più stratificato, alle prese con un
padre violento, dei sogni ingombranti e un fratello scomparso. Su
di lei gravano tutte le pressioni degli adulti attorno. L’emotività
della ragazzina viene resa perfettamente dall’attrice, in grado di
passare dal riso al pianto senza mai sembrare forzata. In generale,
gli interpreti più giovani sono la nota di vanto del film.