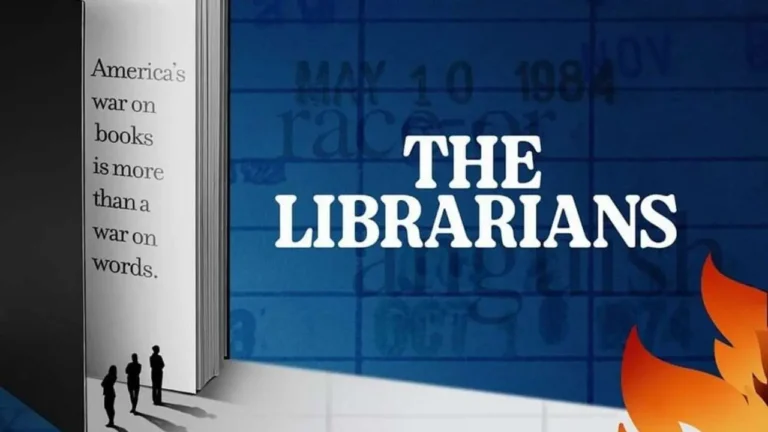Qualche giorno dopo la diffusione della notizia secondo cui Scarlett Johansson era in trattative per entrare nel cast del remake live-action di Rapunzel, la star del cinema ha finalmente rotto il silenzio sulle speculazioni. Il remake ha incontrato notevoli ostacoli nel suo percorso verso il grande schermo.
Secondo quanto riferito, la Disney avrebbe messo in pausa Rapunzel dopo lo scarso successo al botteghino del live-action Biancaneve.
Tuttavia, il progetto è stato ripreso dopo che un altro remake, Lilo & Stitch, ha riscosso un grande successo tra il pubblico.
Durante un’intervista con ET, alla Johansson è stato chiesto se ci fossero buone possibilità che interpretasse Madre Gothel nel film live-action Rapunzel. Lei ha ammesso che “tutto è possibile”, aggiungendo che l’opportunità di lavorare con il regista Michael Gracey è ciò che la entusiasma di più.
La Johansson ha poi descritto Gracey come uno “straordinario visionario” e ha affermato che qualsiasi attore “adorerebbe” collaborare con lui a Rapunzel o a qualsiasi altro progetto.
C’è una possibilità concreta? Penso che tutto sia possibile. Ciò che mi entusiasma è l’opportunità di lavorare con Michael Gracey, che è stato scelto per dirigere il film, perché è assolutamente un visionario straordinario e qualsiasi attore vorrebbe collaborare con lui.
Gracey ha iniziato la sua carriera nell’industria dell’intrattenimento lavorando a video musicali ed effetti visivi. È noto soprattutto per aver diretto il film musicale di grande successo The Greatest Showman.
Gracey ha anche sfruttato la sua esperienza nei video musicali per dirigere il documentario di Pink All I Know So Far e il film biografico su Robbie Williams Better Man, oltre ad aver ricoperto il ruolo di produttore esecutivo nel film biografico su Elton John Rocket Man.
Se Johansson finisse per firmare il contratto per interpretare Madre Gothel, sarebbe la prima star ad unirsi al remake live-action di Rapunzel. Diverse voci online hanno indicato celebrità come Sabrina Carpenter, Florence Pugh e Gigi Hadid, tra le altre, per il progetto, ma finora non ci sono altri attori a bordo di Rapunzel.
La Johansson è nota soprattutto per aver interpretato Black Widow nei film del Marvel Cinematic Universe come The Avengers, Captain America: The Winter Soldier e Black Widow. Al di fuori dell’MCU, ha recitato in film come Lost in Translation, Vicky Cristina Barcelona e Her. Ha ottenuto nomination agli Oscar per i suoi ruoli in Marriage Story e Jojo Rabbit.

Secondo quanto riferito, l’ingresso di Johannson nel cast di Tangled segna un importante passo avanti per il remake, basato sull’omonimo film d’animazione del 2010 con Mandy Moore nel ruolo di Rapunzel, Zachary Levi in quello di Flynn Rider e Donna Murphy in quello di Madre Gothel. Tra gli altri doppiatori figuravano Brad Garrett, Ron Perlman, Jeffrey Tambor, Richard Kiel, M. C. Gainey e Paul F. Tompkins.
Tangled è basato sulla classica fiaba Rapunzel, che era matura per un remake live-action dopo che la Disney aveva fatto lo stesso per diversi altri film, tra cui Cenerentola, Maleficent (basato su La bella addormentata nel bosco), Il libro della giungla, La bella e la bestia, Aladdin e La sirenetta. Tuttavia, alcuni dei più recenti film live-action Disney non sono stati accolti altrettanto bene, con Biancaneve che ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative.
Il successo del live-action Lilo & Stitch ha invertito questa tendenza al ribasso, spingendo i dirigenti a riconsiderare Rapunzel, uno dei film d’animazione preferiti dai fan della Disney.






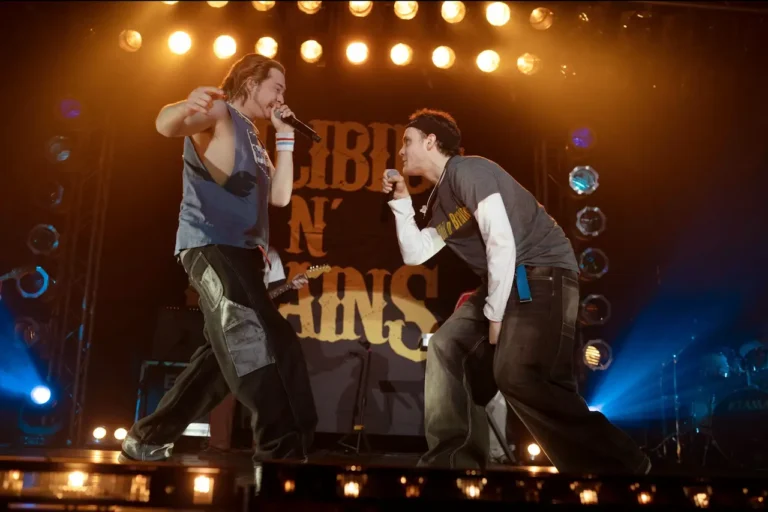

 Eppure, quella che sembra una conquista si trasforma in una nuova esclusione. Nel mondo del lavoro, dove aveva trovato un raro equilibrio, la sua trasformazione la relega dietro una scrivania, tra colleghe diffidenti. Prima, quando non era ancora legalmente donna, le era permesso lavorare in miniera perché formalmente ancora uomo. Dopo, quando finalmente la burocrazia la riconosce in qualità di entità femminile, viene allontanata.
Eppure, quella che sembra una conquista si trasforma in una nuova esclusione. Nel mondo del lavoro, dove aveva trovato un raro equilibrio, la sua trasformazione la relega dietro una scrivania, tra colleghe diffidenti. Prima, quando non era ancora legalmente donna, le era permesso lavorare in miniera perché formalmente ancora uomo. Dopo, quando finalmente la burocrazia la riconosce in qualità di entità femminile, viene allontanata. Lux Pascal, con una prova misurata e profonda, dà vita a una protagonista complessa senza mai scivolare nel melodramma. La sua Carla è vulnerabile ma determinata, lucida e sognatrice. In lei convivono la dignità del lavoro e la dolcezza di chi ha imparato a vivere controvento. Non cerca privilegi, ma giustizia. Vuole solo poter amare, lavorare, esistere.
Lux Pascal, con una prova misurata e profonda, dà vita a una protagonista complessa senza mai scivolare nel melodramma. La sua Carla è vulnerabile ma determinata, lucida e sognatrice. In lei convivono la dignità del lavoro e la dolcezza di chi ha imparato a vivere controvento. Non cerca privilegi, ma giustizia. Vuole solo poter amare, lavorare, esistere.