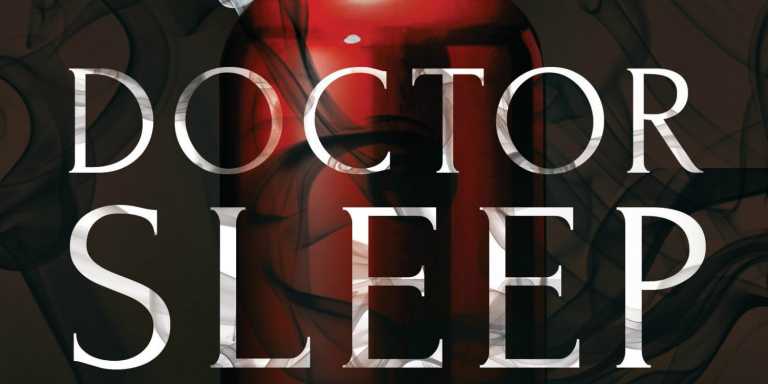Il terzo plumbeo giorno di Venezia 75 si colora e prende vita grazie a due ospiti d’eccezione. Oggi è stato presentato alla stampa, infatti, uno dei film più attesi e chiacchierati del festival, A Star Is Born, opera prima da regista di Bradley Cooper. Ad accompagnarlo c’era, ovviamente, anche la protagonista, una radiosa Lady Gaga.
E’ Nata Una Stella è senza dubbio uno dei classici di genere più amati dal pubblico, film che negli anni ha visto svariati remake. Oggi, alle versioni del 1937 con Janet Gaynor e Fredric March, del 1954 con Judy Garland e James Mason e del 1976 con Barbra Streisand e Kris Kristofferson, se ne aggiunge una quarta decisamente più contemporanea. Il film racconta la storia di Ally (Lady Gaga), una ragazza che sogna di sfondare nel mondo della musica, e del suo incontro con Jack Maine (Bradley Cooper), incontro che le cambierà per sempre la vita.
Diretta da Bradley Cooper – per la prima volta non solo davanti ma anche dietro la macchina da presa – sveste gli estrosi panni di popstar e entertainer e si trasforma in navigata attrice.
“E’ una storia che abbiamo già visto e amato più volte. Questo film parla d’amore, di musica ma anche una storia che affronta il tema della dipendenza da alcol e droghe […] Quando ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica avevo solo diciannove anni e ho lottato come un leone per sfondare, ce l’ho messa tutta perché al contrario di Ally avevo molta fiducia nelle mie capacità […] “
Proprio come Ally nel film anche Lady Gaga nella realtà ha dovuto affrontare mille difficoltà prima di sfondare. Il fatto stesso che tra interprete e personaggio ci sia una tale connessione rende l’interpretazione di Gaga molto più personale e incisiva. Conosciuta e amata dal pubblico anche e forse soprattutto per la sua teatralità – che la rende una perfetta performer -, stavolta Gaga sorprende per il suo look quasi acqua e sapone.
“Cambiare look e giocare con la moda, creando costumi e provando stili diversi è sempre stata una mia passione […] Bradley invece mi voleva semplice, libera e senza trucco, completamente vulnerabile, per lui era importante. Ricordo uno dei primi provini, eravamo a casa mia e avevo sul viso un velo leggerissimo di trucco. Scendo le scale e vedo Bradley venirmi in contro con in mano una salvietta struccante dicendomi: ‘No, voglio vederti completamente pulita’. Ecco, per me la sfida più grande è stata questa, mettermi a nudo e rendermi completamente vulnerabile. Si, ero spaventata ma lui mi ha fatto sentire al sicuro grazie alla sua incredibile professionalità”.
Durante la conferenza stampa di questo pomeriggio Lady Gaga e Bradley Cooper hanno parlato, oltre che della realizzazione del film, anche del loro rapporto personale. In A Star is Born è chiaro sin dalla prima scena insieme che tra i due protagonisti c’è una alchimia particolare.
“Quando ci siamo incontrati la prima volta – ha dichiarato Bradley Cooper – io nemmeno sapevo che Stefani [il vero nome di Lady Gaga è Stefani Joanne Angelina Germanotta] avesse origini italiane. Dopo aver parlato per un po’ ho scoperto che entrambi siamo per metà italiani e forse anche questo ci ha aiutati a legare. Ricordo proprio che questa conversazione è avvenuta davanti a un bel piatto di pasta, cucinato da lei ovviamente […] Lavorare con lei è stato fantastico. Sul set tutti avevano l’impressione di essere a un concerto e non al lavoro. Quando iniziava a cantare tutti restavano incantati ad ascoltare e la temperatura nella stanza cambiava immediatamente”.
A percepire lo stesso tipo di familiarità è la stessa Gaga che ha condiviso con la sala qualche aneddoto dal set di A Star is Born.
“Lavorare con Bradley è stato fantastico. C’è stato da subito molto feeling e rispetto reciproco. Ho capito immediatamente che lui rispettava me come attrice e non solo come cantante e, viceversa, anche lui ha percepito quanto rispetto avessi per lui come regista, attore ma anche come cantante […] E’ davvero un cantante eccezionale; quando canta la sua voce è profonda e viscerale, piena di intensità […] Quando Ally si trova per la prima volta a cantare la sua musica, ecco, quel momento per me è stato così vero e toccante! Quando abbiamo girato eravamo di fronte a un vero pubblico ed eravamo davvero coinvolti. Dopo aver girato la scena più volte, proprio sull’ultimo take Bradley mi ha detto semplicemente ‘Rifacciamola ma stavolta divertiti’. E così ho fatto. Mi sono esibita come se quella per me fosse davvero la prima volta”.
Uno dei temi affrontati da entrambi gli ospiti in conferenza stampa è quello della popolarità e di come questa influenzi la quotidianità di ogni artista. Per raggiungere una certa notorietà bisogna a volte scendere a patti con manager e case discografiche.
“All’inizio mi è capitato molte volte di dire no – ha confessato Lady Gaga –, di rifiutare lavori e ingaggi. Quando ho cominciato non ero di certo la ragazza più bella della stanza ma a differenza delle altre ero io a scrivere le mie canzoni. Spesso mi hanno proposto di scrivere e vendere le mie canzoni per farle cantare ad altri ma ho sempre rifiutato; potevano portarmi via tutto ma non la mia musica! All’inizio molti ti danno consigli su come apparire o cosa dire imponendoti un certo stile ma io sono stata più forte”.
Tenacia e forza di volontà sono state fondamentali per Lady Gaga e la sua carriera ma per il neo regista Bradley Cooper c’è ancora un altro fattore da considerare per scrivere la perfetta equazione del successo.
“Ho dedicato quattro anni di lavoro a questo film e posso dire con assoluta certezza che ogni minuto è stato prezioso […] Potrei stare qui ore e ore a parlare di quanto questa esperienza mi hanno cambiato e arricchito e raccontarvi tutte le cose che ho imparato ma quello che davvero conta sono le persone che credono in te e ti concedono questa opportunità”.
Pensiero questo di Cooper, condiviso anche da Gaga che, nonostante sia ormai diventata una delle più grandi popstar al mondo, ha confessato di aver sempre avuto il pallino della recitazione.
“Ho sempre voluto diventare un’attrice sin da quando ero bambina […] Possono anche esserci cento persone in una stanza e novantanove che non credono in te perché in fondo ne serve solo una per cambiarti la vita. Sono davvero molto fortunata a essere qui”.
Il film A Star is Born, scritto, diretto e interpretato da Bradley Cooper e Lady Gaga è stato presentato oggi, fuori concorso, alla 75esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia e uscirà in tutte le maggiori sale italiane il prossimo 11 ottobre.


























 Girato a 96 fotogrammi al secondo, il film acquista così una fluidità che appunto ricorda quella sinuosa dell’acqua, del suo ondeggiare, e questa scelta di ripresa si sposa perfettamente con ciò che il regista vuole trattare ed esaltare. Il risultato sono delle immagini e sequenze di estrema bellezza, che ritraggono paesaggi ora pacifici ora violenti.
Girato a 96 fotogrammi al secondo, il film acquista così una fluidità che appunto ricorda quella sinuosa dell’acqua, del suo ondeggiare, e questa scelta di ripresa si sposa perfettamente con ciò che il regista vuole trattare ed esaltare. Il risultato sono delle immagini e sequenze di estrema bellezza, che ritraggono paesaggi ora pacifici ora violenti.