Oltre ad essere lo Stregone Supremo, Doctor Strange è anche uno dei personaggi più spiritosi del MCU: quando non è impegnato a lanciare incantesimi o a proteggere l’universo, Strange non può esimersi dallo sparare una battuta sarcastica all’alleato (o al nemico) più vicino.
E’ parimenti noto per i suoi battibecchi con i colleghi eroi, il che ci ha assicurato alcuni dei momenti più divertenti del MCU in assoluto. Ormai i fan attendono con trepidazione le apparizioni di Strange nei film MCU, perché sanno che ci assicurerà battute memorabili.
Questo cos’è? Il mio mantra?
 Ci è voluto un bel po’ di tempo perché Doctor Strange si avvicinasse agli ideali del misticismo e, quando è arrivato al tempio di Kathmandu, si è mostrato molto scettico. Alcuni dei passaggi migliori con protagonista Doctor Strange lo vedono cercare di comprendere ciò che lo circonda.
Ci è voluto un bel po’ di tempo perché Doctor Strange si avvicinasse agli ideali del misticismo e, quando è arrivato al tempio di Kathmandu, si è mostrato molto scettico. Alcuni dei passaggi migliori con protagonista Doctor Strange lo vedono cercare di comprendere ciò che lo circonda.
Nonostante si trovi in una terra sconosciuta e venga ospitato da Mordo, Strange non può fare a meno di fare una battuta sarcastica. Tuttavia, quando Mordo lo informa che la carta che ha appena ricevuto è la password del Wi-Fi, il veterano stregone si fa una bella risata.
“Dovrò… pagare una penale? Una mutilazione, forse?”
 Il battibecco tra Strange e il Maestro Wong ha portato ad una delle amicizie più inaspettate del MCU, e certamente una delle più divertenti. mentre Strange sta acquisendo pian piano le sue abilità di Stregone Supremo si spinge un po’ troppo oltre in biblioteca e viene messo in guardia da Wong sulle terribili conseguenze del furto di libri.
Il battibecco tra Strange e il Maestro Wong ha portato ad una delle amicizie più inaspettate del MCU, e certamente una delle più divertenti. mentre Strange sta acquisendo pian piano le sue abilità di Stregone Supremo si spinge un po’ troppo oltre in biblioteca e viene messo in guardia da Wong sulle terribili conseguenze del furto di libri.
Nonostante le gravi conseguenze che lo minacciano, il presuntuoso Doctor riesce ancora a fare una battuta sotto il naso del Maestro Wong. Anche se Strange non riesce effettivamente a capire quanto Wong fosse serio nel suo avvertimento, è comunque estremamente divertente che si mostri cosi sicuro di sé di fronte al pericolo.
“A differenza di chiunque altro nella tua vita, io non lavoro per te”.
 L’unica persona nell’MCU che potrebbe fare a pugni con Tony Stark in una gara di sarcasmo è lo Stregone Supremo; in Avengers: Infinity War il buon dottore non ha paura di ridimensionare il miliardario e di abbatterlo verbalmente ogni volta che ne ha l’occasione.
L’unica persona nell’MCU che potrebbe fare a pugni con Tony Stark in una gara di sarcasmo è lo Stregone Supremo; in Avengers: Infinity War il buon dottore non ha paura di ridimensionare il miliardario e di abbatterlo verbalmente ogni volta che ne ha l’occasione.
Anche se stanno dalla stessa parte e sono alleati, è ovvio che Strange e Stark non vanno d’accordo e quando Stark cerca di ammonire il dottore per un errore, lo stregone è pronto a ribattere con un bel colpo. Sebbene nessuno possa veramente domare l’arroganza di Tony Stark, l’altrettanto presuntuoso Doctor Strange ha comunque fatto un buon tentativo.
“Be’, vado forte con Google Traduttore”
 Nonostante sia uno stregone mistico e un chirurgo geniale, vi sono comunque state occasioni in cui gli spettatori hanno potuto empatizzare con lo Stregone Supremo. Simile alla sua nemesi Tony Stark, Strange ha reso palese come i personaggi più astuti del MCU siano spesso i più intraprendenti e riescano a risolvere problemi con l’ingegno.
Nonostante sia uno stregone mistico e un chirurgo geniale, vi sono comunque state occasioni in cui gli spettatori hanno potuto empatizzare con lo Stregone Supremo. Simile alla sua nemesi Tony Stark, Strange ha reso palese come i personaggi più astuti del MCU siano spesso i più intraprendenti e riescano a risolvere problemi con l’ingegno.
Il Maestro Wong si chiede come esattamente il mago alle prime armi sia stato in grado di leggere i testi antichi e Strange spiega che ha una conoscenza di base della tecnologia moderna; anche se Strange appare spesso come un pesce fuor d’acqua nel film Doctor Strange, riesce a superare gli stregoni veterani quando si tratta di alfabetizzazione internet di base.
“Non credo nelle favole sui chakra, o sull’energia, o sul potere della fede”.
 Non tutte le battute più divertenti di Strange sono necessariamente tirate fuori al momento, e alcune richiedono del tempo per essere digerite. Quando è arrivato al tempio, Strange era una persona completamente diversa da quella che sarebbe stata una volta che sarebbe divenuto lo Stregone Supremo. La sua crescita lo rende un’affascinante aggiunta al MCU, oltre a uno dei suoi personaggi più memorabili.
Non tutte le battute più divertenti di Strange sono necessariamente tirate fuori al momento, e alcune richiedono del tempo per essere digerite. Quando è arrivato al tempio, Strange era una persona completamente diversa da quella che sarebbe stata una volta che sarebbe divenuto lo Stregone Supremo. La sua crescita lo rende un’affascinante aggiunta al MCU, oltre a uno dei suoi personaggi più memorabili.
Anche se non crede in nessuna delle affermazioni che fa all’inizio del film, è divertente vedere fino a che punto si spinge: è proprio il potere della fede che lo ha salvato in primo luogo, anche se il presuntuoso dottore non ne è consapevole al momento.
Peter Quill: “Quanti ne abbiamo vinti? “Strange: “Uno”.
 Dopo essere diventato lo Stregone Supremo, la presunzione di Strange si è trasformata in una disinvoltura ultraterrena che gli permette di affrontare i multiversi; in Avengers: Infinity War, Strange viene messo di fronte alla sua prova più difficile, per cui deve mettere in gioco la sua capacità di agire a mente fredda.
Dopo essere diventato lo Stregone Supremo, la presunzione di Strange si è trasformata in una disinvoltura ultraterrena che gli permette di affrontare i multiversi; in Avengers: Infinity War, Strange viene messo di fronte alla sua prova più difficile, per cui deve mettere in gioco la sua capacità di agire a mente fredda.
Peter Quill, benchè si dimostri sicuro di sè, finisce spesso per essere tristemente surclassato nel campo dell’intelligenza e le sue interazioni con Strange sono esilaranti; questi lo informa di tutti le potenziali svolte future che ha analizzato e, nonostante la moltitudine di questi, ce n’è solo uno in cui potrebbero avere successo. Malgrado le terribili probabilità, Strange è ancora spassosamente fiducioso mentre Quill lo è meno.
“Non lo so. Non sono ancora arrivato quel punto”
 Prima di diventare lo Stregone Supremo, Strange spesso si confondeva o cercava di far prevalere il suo pensiero critico. Questo tratto è evidente quando comincia a compiere continui errori con testi magici che dovrebbero essere al di sopra delle sue capacità.
Prima di diventare lo Stregone Supremo, Strange spesso si confondeva o cercava di far prevalere il suo pensiero critico. Questo tratto è evidente quando comincia a compiere continui errori con testi magici che dovrebbero essere al di sopra delle sue capacità.
Wong scopre che Strange si sta dilettando con i poteri e lo informa di quanto siano pericolose le sue azioni. Ironicamente, il buon dottore sembra totalmente indisturbato nell’apprendere la distruzione che avrebbe potuto provocare con la sua ignoranza; prima che Strange cambiasse, il suo comportamento mostrava spesso che tendeva a prendere decisioni rapide e impulsive, preoccupandosi delle conseguenze solo in seguito.
Proteggere la tua realtà, imbecille
 Tony Stark e il Dottor Strange sono molto più simili di quanto entrambi vogliano ammettere e quando si scontrano il loro intelletto è alla pari. Sia Stark che Strange sono noti per la loro capacità oratoria, quando si tratta di partorire una battuta intelligente.
Tony Stark e il Dottor Strange sono molto più simili di quanto entrambi vogliano ammettere e quando si scontrano il loro intelletto è alla pari. Sia Stark che Strange sono noti per la loro capacità oratoria, quando si tratta di partorire una battuta intelligente.
Strange ha sviluppato una pazienza tale da tenere testa a Tony Stark, ma è chiaro che ci sono ancora dei limiti a questa sua nuova capacità; quando Stark prova a mettere in dubbio ciò che Strange fa per contribuire al rafforzamento della squadra, Strange si lascia alle spalle tutta la sua sagacia e mette l’arrogante Stark al tappeto con uno dei migliori e più divertenti insulti del MCU.
“Lo dirò a quelli del forno così ti faranno un panino al prosciutto metafisico”
 Anche se il misticismo infuso al suo addestramento lo ha aiutato a diventare una persona migliore oltre che lo Stregone Supremo, Strange è ancora molto legato alla realtà concreta. La pragmaticità di Strange è ciò che alla fine salva la situazione in Doctor Strange e lo aiuta anche ad essere un eroe più efficace nelle sue altre avventure nel MCU.
Anche se il misticismo infuso al suo addestramento lo ha aiutato a diventare una persona migliore oltre che lo Stregone Supremo, Strange è ancora molto legato alla realtà concreta. La pragmaticità di Strange è ciò che alla fine salva la situazione in Doctor Strange e lo aiuta anche ad essere un eroe più efficace nelle sue altre avventure nel MCU.
L’ilarità si scatena spesso quando la concretezza contemporanea di Strange si scontra con i costumi antichi degli stregoni più affermati; quando Wong informa Strange che non possiedono denaro, Strange gli fa sapere quanto lontano li porterà la loro metafisica nel mondo reale.
“Wong. Solo Wong? Come Adele? O Aristotele, Drake, Bono… Eminem”.
 Anche se alla fine si sarebbe tuffato a capofitto nel mondo del misticismo, Doctor Strange si è divertito a prendere in giro anche alcuni degli aspetti più ridicoli di questo: quando incontra per la prima volta il Maestro Wong, non può fare a meno di ironizzare sui ragionamenti astratti del bibliotecario.
Anche se alla fine si sarebbe tuffato a capofitto nel mondo del misticismo, Doctor Strange si è divertito a prendere in giro anche alcuni degli aspetti più ridicoli di questo: quando incontra per la prima volta il Maestro Wong, non può fare a meno di ironizzare sui ragionamenti astratti del bibliotecario.
Anche se alla fine diventeranno grandi amici, i primi giorni di amicizia tra Strange e Wong sono stati a dir poco difficili. Wong, che probabilmente sarebbe stato un Maestro delle Arti Mistiche migliore del Dottor Strange, mostra un’enorme quantità di pazienza con il giovane stregone irascibile, e ha contribuito a plasmare l’identità di Strange, rendendolo la persona che sarebbe diventato. È ovvio che Strange, prima del suo addestramento, si serviva spesso dell’umorismo per deridere tutto ciò che non capiva e Wong era la personalità perfetta per le sue battute.












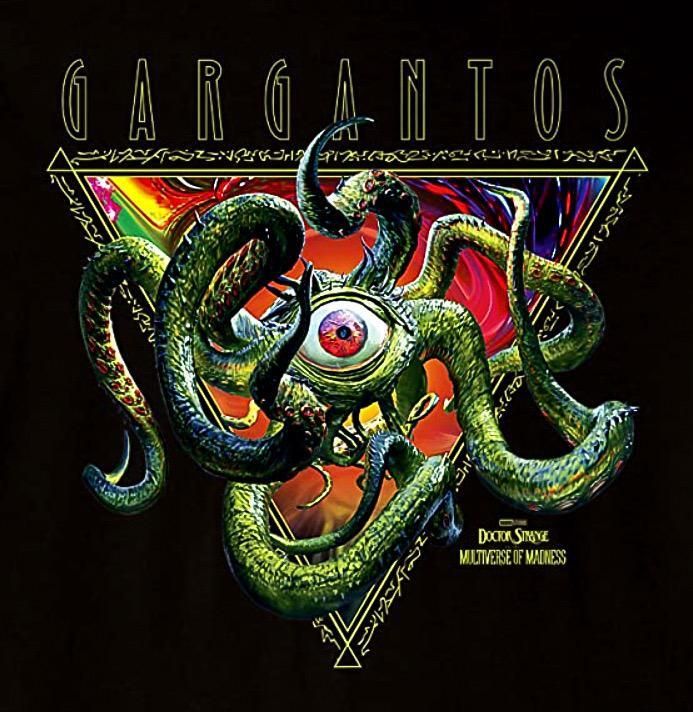




 Farsi beffe della Storia
Farsi beffe della Storia Il cuore di questo divertimento forsennato sono ovviamente le sequenze di lotta corpo a corpo:
Il cuore di questo divertimento forsennato sono ovviamente le sequenze di lotta corpo a corpo: 




 La scena post-credits di
La scena post-credits di  Loki è stato uno degli enormi punti di svolta della Fase 4 del
Loki è stato uno degli enormi punti di svolta della Fase 4 del  Insieme a Sylvie, Loki era lì per ottenere risposte da Colui Che Rimane, dopo che questi aveva illustrato il concetto di linee temporali multiple. A differenza di Sylvie, Loki ha cercato di convincerla che Kang il Conquistatore stava dicendo la verità sul fatto che lui volesse mantenere la pace multiversale, ma lo scetticismo di Sylvie ha avuto la meglio su di lei dopo aver combattuto Loki e averlo spedito in un TVA non familiare.
Insieme a Sylvie, Loki era lì per ottenere risposte da Colui Che Rimane, dopo che questi aveva illustrato il concetto di linee temporali multiple. A differenza di Sylvie, Loki ha cercato di convincerla che Kang il Conquistatore stava dicendo la verità sul fatto che lui volesse mantenere la pace multiversale, ma lo scetticismo di Sylvie ha avuto la meglio su di lei dopo aver combattuto Loki e averlo spedito in un TVA non familiare. Mentre è già stato confermato che Deadpool ha un progetto
Mentre è già stato confermato che Deadpool ha un progetto  Alla fine di Doctor Strange, a Kaecilius è stata concessa la vita eterna nel modo più sgradevole: diventa parte della Dimensione Oscura e sarà tormentato per sempre, il che sembrava essere l’apparizione definitiva del personaggio. Ma il fatto è che Kaecilius è ancora decisamente vivo e potrebbe fare il suo ritorno nel sequel.
Alla fine di Doctor Strange, a Kaecilius è stata concessa la vita eterna nel modo più sgradevole: diventa parte della Dimensione Oscura e sarà tormentato per sempre, il che sembrava essere l’apparizione definitiva del personaggio. Ma il fatto è che Kaecilius è ancora decisamente vivo e potrebbe fare il suo ritorno nel sequel. Anche se l’Antico di
Anche se l’Antico di  Ormai è già stato ufficializzato che Jon Watts dirigerà il prossimo film dei Fantastici Quattro nel
Ormai è già stato ufficializzato che Jon Watts dirigerà il prossimo film dei Fantastici Quattro nel  Il desiderio di vedere come i mutanti sarebbero stati introdotti nel
Il desiderio di vedere come i mutanti sarebbero stati introdotti nel  L’ultima volta che i fan hanno visto Agatha è stata al termine di WandaVision dove è stata surclassata da Wanda e intrappolata nella sua immagine di “Agnes” che aveva raffigurato all’inizio. Anche se alla fine è stata sconfitta, ha dimostrato di avere un grande potere nelle sue mani.
L’ultima volta che i fan hanno visto Agatha è stata al termine di WandaVision dove è stata surclassata da Wanda e intrappolata nella sua immagine di “Agnes” che aveva raffigurato all’inizio. Anche se alla fine è stata sconfitta, ha dimostrato di avere un grande potere nelle sue mani. Nella prima apparizione di Captain Carter in
Nella prima apparizione di Captain Carter in



 Ci è voluto un bel po’ di tempo perché
Ci è voluto un bel po’ di tempo perché  Il battibecco tra
Il battibecco tra  L’unica persona nell’
L’unica persona nell’ Nonostante sia uno stregone mistico e un chirurgo geniale, vi sono comunque state occasioni in cui gli spettatori hanno potuto empatizzare con lo
Nonostante sia uno stregone mistico e un chirurgo geniale, vi sono comunque state occasioni in cui gli spettatori hanno potuto empatizzare con lo  Non tutte le battute più divertenti di
Non tutte le battute più divertenti di  Dopo essere diventato lo Stregone Supremo, la presunzione di
Dopo essere diventato lo Stregone Supremo, la presunzione di 
 Tony Stark e il
Tony Stark e il  Anche se il misticismo infuso al suo addestramento lo ha aiutato a diventare una persona migliore oltre che lo Stregone Supremo, Strange è ancora molto legato alla realtà concreta. La pragmaticità di Strange è ciò che alla fine salva la situazione in
Anche se il misticismo infuso al suo addestramento lo ha aiutato a diventare una persona migliore oltre che lo Stregone Supremo, Strange è ancora molto legato alla realtà concreta. La pragmaticità di Strange è ciò che alla fine salva la situazione in  Anche se alla fine si sarebbe tuffato a capofitto nel mondo del misticismo,
Anche se alla fine si sarebbe tuffato a capofitto nel mondo del misticismo, 











